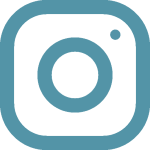Il presidente che ascolta gli scampati e stringe le loro spalle nelle mani, annuisce senza dire niente. Il vescovo ai funerali che formula per tutti un interrogativo, lascia spazio tra le parole.
Non è facile superare con i discorsi il frastuono di un terremoto. Io vi voglio raccontare il mio silenzio.
Prendo il battello per San Giulio, l’isola del lago d’Orta dove c’è un monastero. Tutto intorno, le increspature rispondono con il movimento ai colpi d’aria. Per contrasto, il cerchio di terra, sembra così certo nella sua posizione, ancorato al fondale. Ettolitri di acqua portati a spalla dai fiumi per affogare le parole di troppo: turisti in pantaloncini e oblati accorsi per la messa sono invitati per qualche ora a fare il gioco del silenzio, che è una prova molto seria. Qui questo tipo di digiuno è praticato tutto l’anno, non solo dopo le tragedie, perché la vita è una domanda vertiginosa in continuazione.
Non dire niente significa essere sommersi da una piena di pensieri, ecco la prima ragione per cui rimando quando posso. Stare dritti senza farsi soffocare dall’evidenza, è una prova spaventosa e necessaria. Quando la marea si ritira, col fiatone, resta ancora da duellare con i mostri anfibi che restano in piedi. Il peggiore è la necessità di ragionare, poi l’autocommiserazione applicata alla memoria, infine la pretesa di attenersi alle misure dell’umano. Mi siedo e contemplo quel posto senza rumori che cercavo in Trentino e invece avevo più prossimo del bagaglio a mano. Ecco cosa vuol dire respirare.
In cielo niente crolla, tutto è aria. Il rimbombo si spegne come un’eco lontana, la polvere lascia intravedere qualcosa nel futuro che si sbraccia per chiamarci. Queste vedove serene, velate di scuro, sono pure spose la sera prima della festa.
E quando quello con il Panama, che fa le foto ai gabbiani, tira fuori che in momenti come questo è troppo facile starsene in coro a pregare, io sono certo che non sono loro che si sono chiuse dentro. Siamo noi che ci nascondiamo.
Fonte: Credere