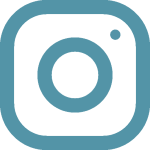Ogni evento storico tende sempre a scomparire dall’orizzonte della coscienza, la Shoah, invece, pone ciascuno di fronte ad una scelta, non è possibile rimanere indifferenti.
La memoria del genocidio nazista non risponde, infatti, ad esigenze di carattere gnoseologico, né soddisfa la curiosità di alcuno; ricordare quell’evento significa farsi carico del dolore del Novecento, assumersi la responsabilità per quanto è stato compiuto, ponendo le basi perché non si ripetano più altri crimini contro l’umanità.
Secondo Hannah Arendt, la Soluzione Finale è stata“an almost complete break”, una rottura profonda tra il flusso della precedente storia occidentale, basata sull’idea di progresso e di civiltà, e l’incerto futuro, segnato dall’annientamento di un popolo e, soprattutto, dalla distruzione ontologica dell’uomo.
Dopo Auschwitz, per Sartre, non è possibile più credere in Dio né, in generale, nella razionalità, sia religiosa che laica, che guida la Storia: il Novecento, dunque, appare come un secolo critico, in cui gli eventi hanno minato al concetto stesso di uomo.
La Shoah, da questa prospettiva, non è stata l’annientamento soltanto di un popolo, ma di ogni Persona, in ogni tempo e in ogni luogo: a tutti è stato tolto il valore della civiltà, tavola di confronto per inquadrare e sublimare le proprie concezioni in un sistema definito e dialettico; a tutti è stata negata la possibilità di testimoniare ideali; si ripropone quell’“appendere le cetre ai salici”, di biblica e letteraria memoria, così che “scrivere poesie dopo Auschwitz è un atto di barbarie” (T. W. Adorno).
Il principio della distruzione è racchiuso in un’icastica espressione di Hannah Arendt, banalità del male: il confine tra gli estremi antitetici di Bene e Male è stato reso labile, poiché la libertà è stata scissa dalla responsabilità; quel binomio, costruito sapientemente da Lévinas, per cui essere liberi significa rispondere al “volto dell’Altro”, è stato cancellato dalla lucida follia di chi si è posto arbitro della vita e della morte per un popolo intero: si pensi a quanto scrive Primo Levi, nella lirica che apre “Se questo è un uomo”: “Considerate se questo è un uomo […]/ che muore per un sì o per un no”.
Eppure, nonostante la Shoah e, anzi, proprio a causa di essa, è necessario fare memoria, assumersi su di sé il dolore del secolo, comprendere che il sistema nazista, senza dimenticare tutte le altre forme di negazione della Persona, è un epifenomeno (M. Giuliani), che nasconde il male radicale della mania di onnipotenza dell’individuo.
La sola memoria del sentimento è insufficiente, provoca una commozione effimera, cieca davanti alle nuove sofferenze; come afferma, infatti, Rav. Roberto della Rocca, “non resta che percorrere quindi la via della perpetuazione del ricordo a monito per i posteri.
Una memoria attiva […] significa per ognuno […] assumere i crimini della storia come male fatto a ciascuno di noi, appartenenti tutti alla grande famiglia dell’umanità.
E significa anche non liberarsi mai passivamente del dolore e del lutto […], ma accettarli come segno permanente di un crimine le cui responsabilità collettive e singole sono assai precise”.
La memoria della Shoah porta con sé l’imperativo sacro del tiqqun ‘olam, del perfezionare il mondo, al fine di rispondere a quel dolore tramite una nuova redenzione, una rinnovata fiducia nel valore della civiltà, perché la Storia non sia un groviglio senza significato, ma sia illuminata dal volto dell’Altro, dal principio della libertà responsabile, perché la sofferenza del secolo non rimanga senza senso, ma riceva un “balbettio di significato” (Hans Jonas).
Pertanto, come afferma Elie Wiesel, “chi ascolta un superstite dell’Olocausto diventa a sua volta un testimone”, in una catena di martiri della Shoah, capaci di rinnovare quell’interrogativo della Genesi: “Adamo, dove sei?” e di rispondere, con altrettanta forza, “Sono nel Volto dell’Altro”.
Andrea Miccichè