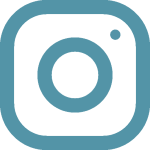Giacomo Poretti: il cuore del paese riparte da un matto sull’Apecar
Di Annalisa Teggi
L‘amatissimo attore milanese ha fatto quattro chiacchiere con noi per raccontare il suo debutto di domani con un monologo teatrale a bordo di un’Apecar. Dopo il lockdown la gente si è messa di nuovo a girare freneticamente, e allora anche il teatro scende in strada a chiedere: ma, tu, dove stai andando?
Suona quasi strano parlare di lui, Giacomo Poretti, senza affiancargli gli amici e colleghi storici, Aldo e Giovanni. Accanto alla scena cinematografica che lo vede protagonista di questo trio consolidato e amatissimo, Giacomo ha intrapreso un’esperienza teatrale nuova insieme allo scrittore Luca Doninelli e a Gabriele Allevi, museologo e organizzatore teatrale. A Milano hanno dato vita al Teatro Oscar-Desidera: si tratta di una proposta culturale orientata dal motto «vivi, ama, desidera». Nell’intenzione di chi si è messo all’opera c’è questa certezza:
Gli uomini e le donne non smettono mai di desiderare, perché in tutti noi c’è la nostalgia di qualcosa che ci supera infinitamente, una sete che nulla può saziare: per questo il nostro desiderio alza lo sguardo verso le stelle. Non con occhi trasognati, ma con lucida attenzione.
E poi, nonostante tutta la convinzione e la voglia di mettersi in gioco, è arrivato il Covid-19 che ha chiuso tutti i casa e ha chiuso tutti i luoghi pubblici, compresi i teatri. Che fare? Dal brusco risveglio in una realtà che spiazza e lascia incerti, è sbocciata l’idea di un moto-teatro, cioé di un teatro che si sposta a bordo di una moto o meglio, di un’Apecar. Lo spazio posteriore di questo storico mezzo di trasporto è un perfetto micropalcoscenico che può ospitare un solo attore, e così il Teatro Oscar – Desidera riprende la sua attività, in luoghi aperti, in forme nuove, rispettando tutte le disposizioni igienico sanitarie. Il debutto è affidato proprio a Giacomo Poretti con uno spettacolo dal nome strano N.O.F.4, dedicato a un personaggio formidabile, Oreste Fernando Nannetti (che visse buona parte della vita in manicomio). Domani, 25 giugno, ci sarà la prima nei chiostri della chiesa di Sant’Eustorgio. Ne abbiamo parlato proprio con lui, Giacomo, a cui abbiamo anche chiesto se non sia indispensabile per l’«economia» di questa ripartenza svegliare i cuori, per non mettere presto nel dimenticatoio l’esperienza della fragilità e del sacrifico che abbiamo appena vissuto.
Caro Giacomo, sono felicissima che tu abbia trovato un po’ di tempo per noi di Aleteia For Her. Ti conosciamo benissimo al fianco dei tuoi amici Aldo e Giovanni. Vorrei far conoscere ai nostri lettori l’amicizia che hai con altri due personaggi, Luca Doninelli e Gabriele Allevi, insieme a cui stai dando vita a nuovo teatro a Milano: il Teatro Oscar – Desidera. Diciamolo in modo ironico: sapevo che era un teatro neonato e ora non solo si è messo a camminare ma ha anche preso la patente per l’Apecar…
Eh sì, mettila così. Volendo scherzare, possiamo dire che grazie al Covid il Teatro Oscar, da neonato, ha saltato tutte le tappe intermedie ed è diventato adulto o almeno maggiorenne e guida. È andata così, perché tutte queste limitazioni ci hanno costretto a pensare qualcosa di creativo, di originale per proporsi alla città e quest’idea di usare l’Apecar come palcoscenico ci sembrava una cosa carina da fare. E partiamo giovedì, eccoci qua.
Quindi tecnicamente ci sarà quest’Apecar-palcoscenico al centro di uno spazio aperto, nel tuo caso i chiostri di Sant’Eustorgio, su cui può stare un solo attore?
Sì, è stata attrezzata a piccolissimo palcoscenico, perché in base alle disposizioni ministeriali ci può stare un solo attore. Quindi noi rispettiamo tutte le disposizioni sanitarie e abbiamo il palcoscenico più piccolo del mondo.
È piccolo, però dietro c’è quest’idea bellissima per cui il teatro si sposta, si muove. Tu, Doninelli e Allevi ci avrete pensato su; a me fa pensare a quei versi di Eliot che dicono «mille vigili che dirigono il traffico non sanno dirvi né da dove venite né dove andate». Mi sa che Milano ha bisogno di questo teatro che va in mezzo alla gente, o no?
È proprio la riflessione che abbiamo fatto. Addirittura nella presentazione iniziale di qualche mese fa del Teatro Oscar, noi cercavamo di dare risposta alle eventuali perplessità di qualcuno che poteva chiedere: «Ma perché un nuovo teatro a Milano, quando ce n’è di meravigliosi e numerosi?». Allora noi diciamo che, intanto, di teatri non ce n’è mai abbastanza. Ma poi il nostro teatro è come la sorellina piccola e ingenua che chiede al fratello, quando sta uscendo: «Dove stai andando?». Siamo convinti che, anche se non li vediamo, che ci sono dei vigili immateriali che ci chiedono continuamente, ogni giorno e ogni momento, dove stiamo andando. Ci chiedono “patente e libretto” e ci chiedono la direzione. Il teatro ha questa funzione qua, di domandarti, tutte le volte che esci, «Dove stai andando?», ma nel senso più profondo della questione. Ecco il motivo di un nuovo teatro a Milano, ecco il motivo di impegnarsi a essere sempre presenti creativamente anche in questo momento di estrema difficoltà. E la difficoltà non è solamente la preoccupazione di riuscire a riempire uno spazio all’aperto, lo dico con molto rispetto. Teatri anche più grossi di noi l’hanno fatto, no? Noi lo stiamo facendo, mettendo tutto di tasca nostra. È un impegno vero, oneroso. Sudato e oneroso. Però siamo contenti di farlo, non c’è nessuna lamentela o rivendicazione. Il teatro deve fare il teatro, punto.
Visto che hai tirato fuori la parola oneroso, mi fai pensare al tema attuale della cosiddetta ripartenza che colleghiamo soprattutto alla sfera economica. Ma la parola economia in origine non si riferiva a spread e profitti, ma alla casa, ai legami familiari. Allora, possiamo fare questa provocazione? Il teatro serve all’economia del paese?
Il teatro, debbo brutalmente, non serve per far soldi ma serve proprio per arricchire la nostra casa interiore, appunto. Poi, io so bene i rischi che ci sono nel fare discorsi formalmente corretti e bellissimi ma che parlano solo a se stessi. Non si può che rispondere così: il teatro, la letteratura, le arti non hanno niente a che spartire col denaro, per quanto sia estremamente necessario. E questa è la grande contraddizione dell’arte, e del sostegno all’arte, in tutti i secoli, per cui senza il benefattore non si fa nulla. Traducendolo in tempi moderni, ed è giusto che sia così, le istituzioni e le regioni e i comuni e le fondazioni hanno preso il posto, o si affiancano, al magnate di turno. E se non ci fosse sarebbe un dramma. Nel piccolo, anche per noi è così: una fatica immensa nel teatro è quella di chiedere ad amici di sostenere il progetto che hai a cuore. Va detto senza ipocrisia.
Ci vuole sincerità e un briciolo di follia in queste imprese. E lo spettacolo con cui tu debutti domani (giovedì 25 giugno) è dedicato a un personaggio formidabile, che è rimasto chiuso in manicomio, Oreste Fernando Nannetti. Il titolo del tuo monologo è proprio “N.O.F.4”, come Nannetti si firmava nelle lettere immaginarie che scriveva dall’ospedale psichiatrico di Volterra in cui era stato ricoverato. Dunque, paradossalmente, tu adesso porti la voce di un matto al nostro paese che si è appena confrontato con una pandemia?
Sì, propongo la voce di un matto. Era già lì questo testo. Non è stato pensato alla luce della pandemia, era lì. Avevo scritto il testo e l’avevo messo in scena una volta soltanto, però ci sono molto legato perché mi dà modo di riflettere sul significato dell’arte, sul suo significato profondo, quindi sul significato della comunicazione e quindi sul senso della vita. Io ho cercato di affidare a lui le risposte alle grandi domande della vita e, lo sai bene, sono risposte quasi impossibili, no? A volte sono delle aporie, ecco. Ho cercato di affidare queste risposte a un matto, anzi a dei matti. Parlerò di Fernando Nannetti, che è il protagonista, e con lui mi piacerà riflettere soprattutto sulla fatica, per non dire sulla sofferenza sanguinosa della produzione artistica. Questo mi ha colpito in lui ed è quello che mi ha colpito anche in altre figure, tutte di cosiddetti outsider cioé di artisti non consapevoli. Parlerò anche di Ferdinand De Cheval, il postino di Hauterives, che ha dedicato trent’anni della sua vita a costruire il Palazzo ideale. Parlerò anche di Robert Walser, mi interessano molto questi outsider. Che sono i matti, che però danno delle risposte. Certo sì, criptiche e misteriose, ma eccome se rispondono. Queste risposte le teniamo lì a disposizione di tutti, accanto alle altre risposte che anche la politica e l’economia danno in questo tempo di pandemia.
Oreste Fernando Nannetti (1927-1994)
Nato a Roma alla fine degli anni Venti, figlio di padre ignoto, a soli sette anni fu affidato ad un’opera di carità, e a dieci ricoverato in una struttura per persone affette da problemi psichici. Dopo una lunga degenza ospedaliera per una grave forma di artrite degenerativa, nel 1948 fu processato per oltraggio a pubblico ufficiale e fu contestualmente giudicato incapace di intendere e di volere, finendo in vari nosocomi della capitale fino alla definitiva collocazione nell’ospedale psichiatrico di Volterra (oggi abbandonato) in Toscana, dove visse sino alla morte.
Durante l’internamento incise con la fibbia del suo gilet due graffiti di 180 metri per 2 e di 102 metri per 20 centimetri sulle pareti dell’ex ospedale psichiatrico di Volterra. In questi graffi/graffiti spigolosi è incisa una fantasia caotica e geniale, un’immaginazione potente e bisognosa di legami. È uno dei maggiori esponenti dell’Art Brut (arte grezza) in Italia nel Novecento.
Ferdinand Cheval (1836-1924)
Un postino francese con una smisurata passione per la scultura, dedicò 30 anni della sua vita a costruire un Palazzo ideale. Lasciò la scuola a 13 anni per diventare apprendista panettiere, e poi divenne postino; ma fantasticava su questo edificio fiabesco che ora è ritenuto un capolavoro, anch’esso dell’Art Brut. Cheval era solito raccogliere pietre ovunque e riporle nelle tasche o nella borsa a tracolla che portava con sé; presto gli abitanti di Hauterives lo considerarono un eccentrico.
L’edificio, la cui costruzione ha richiesto l’impiego di circa 100.000 pietre ed è riconosciuto come monumento nazionale francese, non contiene stanze o ambienti abitabili, ma soltanto un labirinto costituito da un insieme di corridoi, grotte, camminamenti e terrazze che si sviluppano in modo fantasioso.
Robert Walser (1878 – 1956)
Poeta e scrittore svizzero di lingua tedesca. Fu prima apprendista in una banca poi tentò senza successo la via del teatro. Si trascurò e i suoi disturbi fisici e psichici lo portarono all’internamento in una clinica psichiatrica, dove trascorse gli ultimi 28 anni della sua vita. Solitario e scontroso, portato dall’osservazione realistica a risalire alla trasfigurazione surrealistica, sempre sconcertante e propenso a una dolorosa ironia. Kafka ravvisò in lui un suo precursore su molti temi. Walter Bejamin ha detto di lui: «Walser comincia dove cessano le fiabe».
Sbaglio se dico che le loro non sono risposte come quelle che si danno ai quiz, ma di quelle che aprono le nostre ferite? Vedo che la gente ha tanta voglia di raccontarsi dopo questo lockdown, il contagio ci ha fatto riscoprire il senso della parola fragilità, il senso della parola sacrificio. Forse il teatro è il luogo per digerire assieme questa esperienza, per depositarla nella coscienza?
Sicuramente sì, per me e per Doninelli e Allevi è così. Dobbiamo annaffiare sempre e tenere in vita certe domande e certe parole, che poi sono concetti. Ho dedicato uno spettacolo anche all’anima e non è semplicemente una parola, spalanca un mondo.
Senti, se dico che ho fatto una chiacchierata con te e siamo stati così seri, nessuno mi crederà. Allora possiamo dire che anche la chiave dell’ironia, che è una delle tue cifre migliori, è quel modo di dare risposte in modo da aprire finestre anziché chiuderle?
Sicuramente. Se il Padreterno e la mia amicizia con Aldo e Giovanni non mi avessero regalato questo tipo di linguaggio che è l’ironia, non potrei raccontare né dei matti come Nannetti né dell’anima. Io non propongo un saggio critico, ma un percorso che utilizza l’ironia e la surrealtà per arrivare a quelle domande profonde di cui parlavamo prima. L’ironia e i suoi codici sono fondamentali, certo.
A fronte di tanta originalità che è venuta fuori dalle tue riflessioni, voglio farti la classica domanda che si sente molto in giro adesso: usciremo migliori o peggiori dal Covid 19?
Non lo so, se lasciassi parlare il pessimista che è in me ti direi: non è cambiato niente. Non è cambiato assolutamente niente. E’ vero che il Covid ci ha dato questa immensa opportunità, e resterà in giro ancora per un po’, non tanto di cambiamento ma di riflessione. Quello sì. Forse rischio di essere moralista e non voglio esserlo: se giudicassi solo dagli aspetti pubblici, non colgo trasformazioni. Sto parlando al di là di quello che accade alle persone singole. Io non ho mai creduto, se non quando ero adolescente, alle rivoluzioni di massa e ai cambiamenti di massa, sono più propenso a puntare tutto sull’individuo. Cambiamento è una parola che non mi piace; sicuramente in molti di noi, personalmente, questo evento ha fatto effetto, ma pubblicamente mi pare tutto uguale.
Fonte: Aleteia