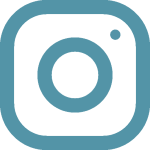Alessandra Morelli, una vita all’UNHCR a fianco dei rifugiati.
La cultura della paura e la cultura dello scarto viaggiano di pari passo e, in certi momenti della storia del nostro Paese, si intrecciano indissolubilmente.
I flussi migratori, al centro del dibattito politico-elettorale, sono divenuti un topic di sicuro effetto per gli opposti schieramenti.
Il fatto che colpisce negativamente è che si parli di migranti e non di persone, di uno status e non di un’identità.
Formare la coscienza sociale vuol dire anche farsi prossimi e, per un aiuto in questa prospettiva, abbiamo intervistato la dott.ssa Alessandra Morelli, senior advisor dell’UNHCR, attiva su più fronti per garantire i diritti di quanti sono oppressi dalla violenza e dalla povertà e intraprendono viaggi della speranza, per un avvenire (forse) migliore.
Il suo mandato la pone a stretto contatto, anche a livello istituzionale, con il dramma dell’immigrazione: quale visione d’insieme può trarre sul fenomeno?
Ogni volta che cerco di definire il problema migratorio, mi accorgo che il rifugiato, forse come nessun altro, è colui o colei che scuote le coscienze e divide l’opinione pubblica.
L’Europa, a differenza di altre regioni del mondo, si sta affacciando solo da poco alle ondate migratorie di questa portata, reagendo in modo contraddittorio, da un lato ostile, dall’altro ospitale. L’immagine che connota il nostro continente è, purtroppo, il muro – fisico, sociale, legislativo – che vorrebbe proteggere la nostra civiltà dall’alterità che spaventa.
Il prezzo della solidarietà è alto, ma è l’unica scelta razionale e responsabile per affrontare la situazione; altrimenti, ed è questo il rischio che stiamo correndo a livello politico, si apre un baratro di incapacità nel gestire il dramma umanitario. Come afferma l’Alto Commissario Filippo Grandi, la solidarietà deve essere sistematica: lo slancio emotivo per la morte del piccolo Aylan Kurdi o per altri casi limite, senza che a ciò segua un’opera duratura, non basta più.
Alla xenofobia si oppone l’integrazione: quali “best practices” per promuovere l’incontro tra culture?
L’unica via per superare l’impasse è un’integrazione rispettosa, non un’omogeneizzazione di culture: accoglienza vuol dire creare spazi di dialogo. La vera “best practice” è creare un “terzo spazio”, equidistante tra le culture in gioco, in cui si realizza l’ascolto tra le paure. Interculturalità non è annientamento, ma riconoscimento delle differenze e, proprio attraverso le differenze, individuazione di un punto d’incontro, che è il nostro essere persone.
L’emergenza rifugiati, se gestita correttamente e con empatia, può divenire l’opportunità per rompere i muri di paura che ci tengono in ostaggio.
Invece, sul piano internazionale, quali soluzioni si profilano?
A livello internazionale, è necessario intervenire in un contesto di conflitto globale asimmetrico: mentre prima era abbastanza agevole individuare l’interlocutore con cui discutere, oggi non è più così; si combatte su più fronti con una scarsa caratterizzazione delle parti.
Non è più possibile muoversi a livello individuale: gli interessi egoistici degli Stati devono cedere di fronte all’urgenza della cooperazione.
Ricordiamo, poi, che circa il 90% dei migranti non arriva nel cosiddetto Nord del mondo, ma si rifugia nei Paesi limitrofi, anch’essi colpiti dal flagello della guerra: basti pensare al Kenya, all’Etiopia, al Libano. È responsabilità dei Paesi occidentali rendere sostenibile questa situazione.
Purtroppo, siamo lontani da questo obiettivo fondamentale per consolidare la pace: è sotto gli occhi di tutti l’incremento dei conflitti, che vanno ad aggiungersi alle crisi croniche: dalla Siria all’Ucraina, dalla Somalia all’Eritrea, dal nord del Mali all’Afghanistan, dal Sud Sudan alla Repubblica Democratica del Congo.
Si tratta di movimenti migratori che coinvolgono milioni di persone: sono più i rifugiati che le soluzioni!
Eppure i media non presentano la situazione in questi termini…
Noi dell’UNHCR siamo consapevoli che il potere mediatico è tra i più forti e incisivi nella nostra società: cerchiamo sempre di divulgare l’opera che svolgiamo, affinché tutti possano “uscire” dai limitati confini del proprio Paese per aprirsi ad un’ottica inclusiva e accogliente.
Più che dare informazioni, offriamo le nostre testimonianze di vita e di “missione”: è toccando le corde della sfera empatica che si entra nel vero dialogo.
Rapportarsi con i media vuol dire compiere un’attività di educazione e le risposte positive, anche se dopo tempo, arrivano.
Dalla testimonianza alla provocazione: lei svolge una missione di forte responsabilità e ad alto rischio, ha subito addirittura un attentato; se dovesse fermarsi un attimo, pensando anche al futuro, cosa la spinge a continuare nel suo impegno?
Sempre nella vita, quotidianamente, si compiono scelte e ci si ferma a dire: “Ma chi me l’ha fatto fare?”; una prima risposta può essere a livello dei principi, perché ciò che mi ha portato a svolgere questa missione è stato il senso di responsabilità nella difesa dei diritti umani e della dignità. Il mandato dell’UNHCR permette di entrare in una famiglia formata da quanti, come me, hanno a cuore la sacralità della persona.
Coraggio, solidarietà, accoglienza, rispetto sono le parole sacre che mi danno slancio per continuare. E queste parole hanno un volto: ho avuto l’opportunità di rincontrare alcuni rifugiati che, al tempo della guerra in ex-Jugoslavia, erano stati reinsediati in Italia e, poi, in Canada.
Incontrarli per strada e sentirsi chiamare per nome, vederli riappropriati dei sogni e della dignità, con figli, un lavoro, con i miei stessi diritti.
È commovente, ma è la magia dell’incontro che ci permette di crescere nel “noi” e di andare avanti.
Andrea Miccichè