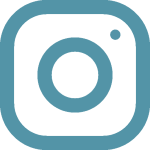I ragazzi sentono la vita che c’è dietro ai professori.
Ora, io non sono Ambrogio Fogar, però nemmeno un giovanotto appena uscito da una rapida e appagante esperienza universitaria. Iniziando a fare l’insegnante, mi sono presentato in aula con un bel carico di esperienze, delusioni, sbagli anche gravi, tentativi estremi. Così, quando ho avvertito che i miei alunni mi stavano provocando con le loro fatiche, con il racconto delle loro stupidaggini commesse al sabato sera, non mi sono impressionato più di tanto. Non li ho nemmeno giudicati perché, vent’anni fa, ero con loro in quel pub. Conosco il desiderio dell’autodistruzione, mi sembra normale se la vita si propone, a chi ha i sensi spiegati, senza indicare che l’assurdo può diventare religione. Il problema del sacrosanto sbandamento adolescenziale è che comporta un rischio vero: in casi gravi, se ne può morire. Così si perde l’esperienza di un futuro che spesso val la pena di visitare (il mio valeva).
Il mio sguardo di sufficienza sulle loro eroiche trasgressioni ha fatto drizzare le orecchie a quelli del banco in fondo. I peggiori della classe sono i migliori, ma non vanno idealizzati: sono dei gran rompiscatole e spesso non mi permettono di fare fino in fondo quello che mi piace fare (ragionare sulle parole degli autori). Però hanno un privilegio che non gli si può negare: odiano studiare perché sentono la vita come una domanda grave e urgente; un interrogativo che non va imbrigliato nelle risposte scritte di nessuno, che va bruciato, più che letto e raccontato. Per loro i libri sono una versione depotenziata delle esperienze vere, quindi una perdita di tempo (e io, in molti casi, sto con loro).
La parola (se non è la Parola), balbetta la vita senza esserlo del tutto. Per chi ha pomeriggi liberi, tranquillità e una famiglia che lo sostiene, l’indagine metodica e pure appassionante dello studio è una solida scala verso il vero. Ma i ragazzi peggiori stanno in bilico sull’orlo di una fine che li vuole di continuo divorare. Non hanno tempo per le note esplicative. Cercano disperatamente un ascensore che conduca al piano – Soluzione -, e a volte lo scambiano persino con il gesto di farsi fuori.
I miei errori del passato sono l’unica cosa che davvero stringevo quando si è trattato di salire sul gradino della cattedra. Ho l’impressione che chi tra i miei alunni è disposto a starmi a sentire, mi stimi più perché a sedici anni fumavo un pacchetto al giorno, che per il fatto che so parafrasare le tre Cantiche. Guadagnato un bel rapporto, il problema è capire di cosa dobbiamo parlare. Io penso sia mio dovere trasmettere loro il senso che ho incontrato, ma le volte che ho provato a dirlo tutto insieme, si sono girati dall’altra parte, come fosse un bagliore troppo intenso. La questione, quindi, è come ridurre questa eredità immateriale al grado zero; proporre Dio, addirittura, ma in un discorso nel quale sono tabù tutte le parole che loro hanno già sentito in chiesa e all’oratorio (password per disattivare i ricettori). E poi c’è un altro interrogativo: come correggerli, se intimamente sono sicuro che i loro sbagli non rappresentino un vero male, perché li renderanno persone più capaci di empatia con chi ha problemi?
Ecco i nodi attorno ai quali si attorciglia (e poi, spero, si scioglie), la riflessione del mio piccolo romanzo che si intitola LA REGOLA DI KURT. È la storia di un liceale che scopre di avere se stesso invecchiato come professore. Riusciranno a stare uno di fronte all’altro?