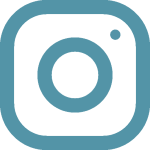Se sei un tipo “social” hai sempre un telefono, un tablet, un pc con te, se no sei “a-social”, fuori dal mondo sia reale che virtuale.
Una volta il termine “sociale” era riferito specialmente al mondo del volontariato, ad un certo tipo di comunicazione attenta ai problemi della gente, ai centri di aggregazione. Oggi, pur mantenendo questi significati, il più noto e diffuso fa riferimento al web, cioè “social network”.
In questo ambito si riveste di nuovo ciò che già c’era, si moltiplica per l’intero pianeta ciò che prima era il semplice ritrovarsi in piazza, al bar, a casa di amici, a teatro, al cinema, allo stadio, al parco, in spiaggia. Tutto questo ora può essere tenuto in mano, portato nel taschino della giacca e dei jeans, posto sul tavolo da lavoro, conservato nella borsetta; bastano un telefono, un tablet, un pc, una connessione, i giga adeguati!
Se sei un tipo “social” hai sempre uno o più di questi strumenti con te, se no sei “a-social”, fuori dal mondo sia reale che virtuale.
Ma ormai che senso ha fare differenza tra reale e virtuale?
I piani si confondono facilmente, le nuove generazioni non trovano spesso le differenze, gli adulti si adattano con più o meno difficoltà, la tecnologia supera se stessa continuamente, la pubblicità dà chiari messaggi in questa direzione. Eppure c’è qualcosa che non convince del tutto, forse a volte spaventa pure.
È come se la vita sfuggisse di mano e fosse consegnata a qualcuno che non conosciamo con una fiducia straordinaria e illimitata mai data ad altri seppur noti.
Le pagine dei social su internet sono piene di notizie, dati, foto, storie, racconti personali, diari intimi, questioni che “un tempo” – possiamo ben dirlo – si raccontavano solo alle persone di fiducia, agli amici più stretti.
E come se, gettati in questa rete, pensiamo di essere liberi e di conoscere sempre più
Quando invece tutto è costruito per sapere chi siamo, quali desideri abbiamo, quali inclinazioni, perché ci possa essere offerto l’oggetto agognato, il prodotto ambito. I profili o diari personali più che sociali, cioè aperti all’altro da sé, appaiono in molti casi come luoghi in cui l’egocentrismo fa a gara con la vanagloria, in cui paradossalmente, mentre si crede di essere in tanti, ci si ritrova soli a guardare e riguardare quella pagina in attesa che qualcuno ci dia un minimo segno, la speranza di avere un seguito, quasi l’elemosinare un “Mi piace”. Non solo! Dovremmo essere “social” e dunque più aperti, eppure ci chiudiamo anche fisicamente in una specie di guscio incurvandoci sul nostro smart-phone, ci chiniamo “devoti” dinanzi al pc, ci specchiamo negli schermi dei tablet in attesa di essere definiti i più belli del reame.
Dovremmo creare rete, un network appunto, in realtà siamo caduti in una rete, né più né meno che quella di un ragno.
Fitta come quella per i pesci, entrambe con maglie che ci tolgono il respiro, la personalità, l’identità, la volontà, il tempo, le relazioni, gli affetti, la libertà. C’è allora una via d’uscita? Ci sono valori da cogliere? Si deve tornare indietro nel tempo?
La via d’uscita, per assurdo, è un percorso di entrata, cioè di starci dentro con competenza, equilibrio, conoscenza, temperanza, saggezza, leggerezza.
I valori hanno solo bisogno di essere messi in luce, rifuggendo le banalità e le ovvietà, puntando l’attenzione sul recupero e la cura delle relazioni nelle situazioni di lontananza fisica, sulle reti di solidarietà, sulla voce che viene dal basso per gridare ciò che certi mass media tacciono, sulla messa in circolo di vere buone notizie. Non ha, dunque, senso tornare indietro, ma è più importante puntare verso l’alto, trasformando il mondo virtuale in un “mondo virtuoso”, valorizzando le potenzialità dello “strumento” per metterle a servizio della persona, dei più deboli, dei malati, di chi è solo, di chi è impegnato a costruire ponti e abbattere muri.
Che il “social” torni ad essere “sociale”, quindi a far stare bene chi ne fa uso, a riunire le famiglie, a creare legami positivi, a stimolare la cultura, a generare una civiltà per la pace, a riavvicinare i lontani; che il “network” torni ad essere una rete che salva come quella di sostegno al trapezista, come quella su cui si gioca a saltare più in alto divertendoci, come quella che sostiene i materassi su cui riposiamo dolcemente, come quella che si intreccia nel momento di bisogno di qualcuno o della collettività.
Marco Pappalardo