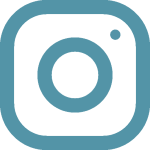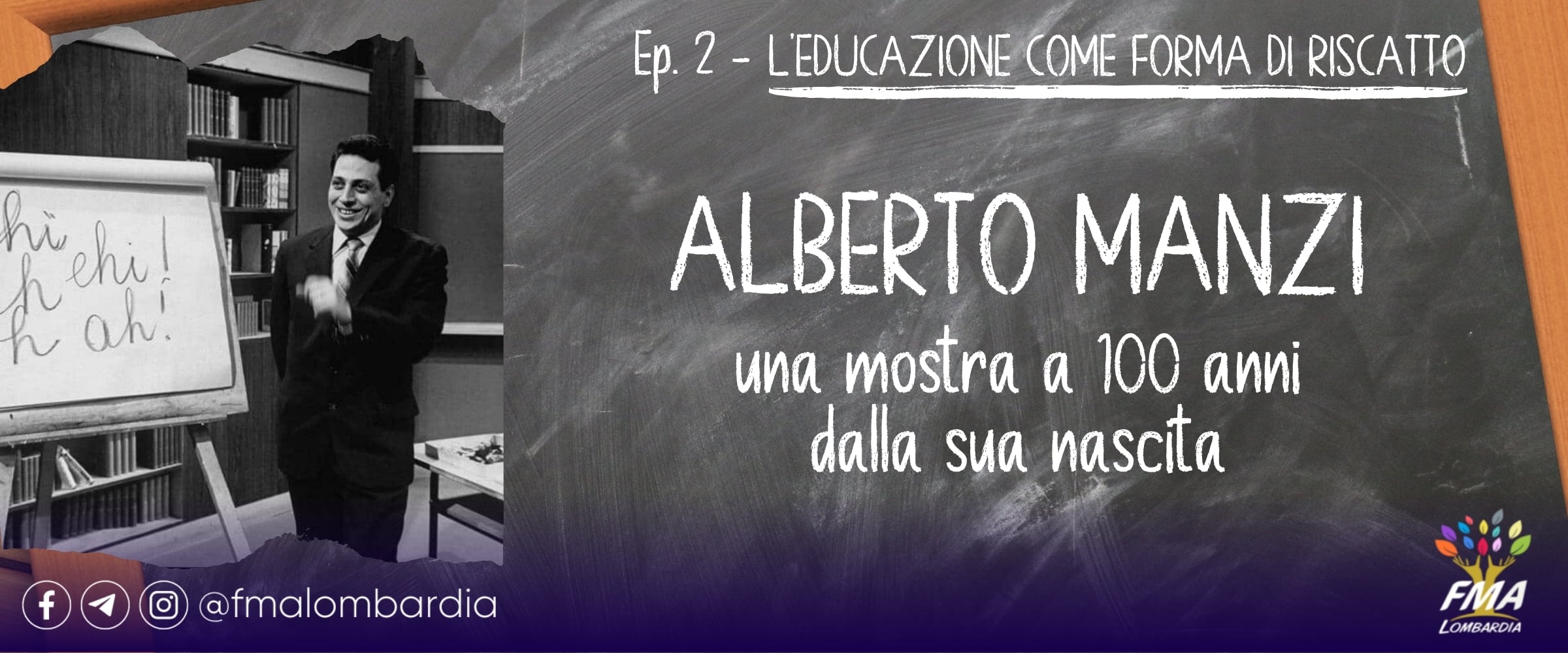Continuiamo il nostro approfondimento sul maestro Manzi con l’intervento della dottoressa Mor, responsabile del C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Rho. Il C.P.I.A è un’Istituzione Scolastica del Ministero della Pubblica Istruzione rivolta ai cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto i 16 anni di età.
Episodio 2: L’educazione come forma di riscatto
Per il mio intervento vorrei partire da un’opera che hanno realizzato i bambini per la mostra, nella quale hanno descritto sinteticamente Manzi come : “docente, pedagogista, scrittore e politico italiano”.
Manzi è insegnante, educatore in Sudamerica, uomo di spettacolo, e uomo. Come lui anche noi viviamo tante identità che si manifestano rispetto al ruolo sociale, ruolo che può essere esteso oppure più ridotto, se per esempio siamo all’interno della famiglia; la nostra identità si forma grazie a questo ruolo sociale, e a tutte le esperienze che facciamo.
Con questi tanti noi incontriamo l’altro. Sono noi complessi, non sempre in equilibrio, che rispecchiano anche la complessità della vita.
Nel quotidiano, poi, incontriamo altri noi, anch’essi fatti di tante identità. A volte intuiamo l’identità di chi ci sta di fronte, ma spesso dobbiamo fermarci per poterle ascoltare e comprendere veramente li volto che abbiamo davanti.
Ho trovato un pensiero di Hannah Arendt che sintetizza bene questo concetto e la complessità che ci contraddistingue: “Non l’uomo, ma uomini abitano questo pianeta, la pluralità è la legge della terra”.
Ma mentre ci viene comodo definirci complessi – perché è un aggettivo che ci piace, perché vuol dire che non siamo subito leggibili – ci risulta più difficile fermarci a riflettere per capire quali sono le condizioni per accettare la complessità degli altri.
Manzi ci suggerisce che questo è possibile grazie alla disponibilità, alla ricerca e al conflitto. Ho scelto la parola conflitto perché quando entrano in contatto diverse culture la storia, anche quella recente, ci insegna che il conflitto è molto presente. Manzi però invita a vivere il conflitto con un’accezione molto bella: il conflitto è necessario, fa parte della vita, ed è un conflitto buono, perché indirizzato a un miglioramento, a un obiettivo. Avere un obiettivo è ciò che mi dà la mia misura e la misura dell’altro.
Mi piace molto anche questo richiamo alla fisicità. Poco prima ci siamo soffermati al bisogno di entrare in contatto, e anche in conflitto, con i ragazzi, ad esempio del carcere. E questa fisicità che ci ricorda anche che ciò che è lecito in una cultura non lo è in un’altra e quindi i fraintendimenti sono molto semplici, all’ordine del giorno.
A volte è necessario, per non entrare in conflitto, fermarsi molto prima e non fare passi affrettati. Se stiamo fermi siamo al sicuro, non possiamo sbagliare. Se occorre prendersi uno spazio per osservare l’altro va bene, ma dopo bisogna anche muoversi ed andare incontro, l’osservazione non può essere una scusante per non fare mai il primo passo ed evitare di incontrare l’altro.
Al C.P.I.A. lavoro tutti i giorni – ho questa grandissima fortuna – con adulti stranieri e con ragazzi intorno ai 16 anni che non sono riusciti a trovare nella scuola “ normale” la loro collocazione, quindi ragazzi a forte rischio.
Tutti i giorni la mia identità viene un po’ circoscritta, nel senso che sono solo un pezzettino rispetto a un sapere molto grande che c’è intorno a me. Tutti i giorni, vedo e vivo la fatica degli adulti che si mettono di nuovo in gioco, che devono ricollocarsi rispetto alla professione – anche importante – che hanno svolto nel loro paese d’origine ed ora non è detto che possano continuare; oppure penso alle tante signore che sono venute in Italia non per scelta, ma perché hanno seguito il marito e che poi, per una serie di ragioni, non fanno parte della società, non sono del tutto integrate. Molti di noi probabilmente, quando accompagnano i figli a scuola, incontrano gruppi di signore che provengono dalla Tunisia o dal Marocco che non parlano la lingua italiana. Eppure, se gli si chiede da quanto tempo sono in Italia, si scopre che vivono qui da cinque o sei anni. E questo è un dato che fa molto riflettere rispetto al grado reale di integrazione.
Gli adulti hanno poi delle caratteristiche che li rendono un po ‘più fastidiosi rispetto ai bambini, e solitamente siamo meno indulgenti verso di loro. L’adulto pretende, vuole concludere rapidamente le pratiche perché ha delle scadenze più pressanti; e tutto ciò rende la mediazione complessa, difficile. Vi mentirei se dicessi che in realtà è tutto piacevole e tutto bello.
C’è un atto di responsabilità molto grande anche nei confronti di persone che arrivano e che devono essere aiutate a mettersi in gioco per entrare a far parte della società. Qualche volta respiriamo un’aria del genere “mi aspetto che tu mi aiuti”. E ci viene anche tanto comodo aiutare, senza permettere all’altro di attivarsi realmente.
In questo frangente le parole hanno un grande peso, soprattutto quando l’altro non parla la stessa lingua. Anche qui Manzi è molto accorto e può illuminarci una citazione presa dal “L’avventura di un maestro”: Manzi lavora sull’economia delle parole, la cui conoscenza deve diventare anche coscienza del loro lavoro.
Quando spiega, quando parla, quando incontra l’altro i pensieri sono chiari, sono puliti. Non ci sono troppi giri, non ci sono troppe immagini, non ci sono troppe apparenze e cose, c’è molta sostanza, è per quello che il messaggio arriva. E credo che abbiano bisogno di questo le persone che stanno imparando ad approcciare una nuova lingua, una nuova cultura: l’essenzialità. Perché questo permette all’altro di capire, e anche di cominciare a mettersi in gioco a sua volta, se invece io completo tutte le frasi al posto dell’altro, non gli permetto di attivarsi.
Manzi ci ricorda anche che chiunque si occupi del futuro delle generazioni – educatori, genitori -vivono un grande paradosso: ci viene chiesto di essere delle guide, ma delle guide non troppo opprimenti; dare indicazioni, però non troppe; dettami da seguire, però lasciare libera la creazione dell’identità. Si tratta di una ricerca dell’equilibrio – sempre molto precario – in un lavoro quotidiano, minuzioso, noioso. La quotidianità è noiosa: è fatta di banalità, che poi tanto banalità non sono, la somma delle quali però danno la misura di un’integrazione che si rivela o meno vera.
Se penso ai miei studenti, qualche volta sono l’unica insegnante che hanno conosciuto nella loro vita, perché non tutti hanno potuto studiare, e quindi sono adorata. Non so quanti insegnanti possono dire altrettanto e fare la stessa esperienza: quando io entro nel corridoio, mi dispiace dirvelo, ma la regina di Saba è niente a confronto.
Ma anche questa eccessiva valutazione del mio essere docente è un grande pericolo, perché mi chiede di ridimensionare la mia figura, per non cadere nella sopravvalutazione di me stessa. Perché non è vero che sono l’ideale, non è vero che c’è la perfezione.
E anche qui Manzi invita i suoi alunni a non vivere come una copia: l’educatore o l’insegnante è un riferimento, ma non il tutto da riprodurre tale e quale, l’alunno è altro e deve costruire la sua identità. Sicuramente prenderà qualcosa dal riferimento che ha davanti, però poi è chiamato a costruire il suo sé, la sua identità, creando qualcosa di diverso e nuovo..
Passiamo ora a un’altra fetta che contraddistingue il ruolo, anche pubblico, degli insegnanti: parlare davanti alle persone; anche con diverse tipologie di interlocutori.
Manzi è stato un uomo di spettacolo, qualche volta ce lo ricordiamo solo per la trasmissione “Non è mai troppo tardi”, perché è la parte più nota della sua vita, quella con cui ha sfondato, che ha oscurato un po’ le altre.
L’invito è quello di mettere a disposizione le capacità che si possiedono: sai fare questa cosa, mettila a disposizione degli altri.
La trasmissione funziona perché Manzi guarda in faccia i suoi interlocutori. Una delle cose che arrivava era proprio lo sguardo, era come se parlasse con te, con ognuno. E quella capacità non è finta: o ce l’hai , o non ce l’hai. Quello sguardo arriva e il messaggio arriva, è quello che sopravvive al tempo. Questa cosa si fa anche al centro, in classe: quando non hai tanti strumenti per parlare, quando le persone che hai davanti conoscono solo l’alfabeto, devi usare anche altro oltre alle parole, devi usare lo sguardo. E funziona, anche se poi non può bastare, ed entra in gioco l’altro pezzettino che è la riattivazione delle persone.
Ci sono molti autori che si riferiscono a Manzi o che lo riprendono, c’è molta bibliografia, ora però vorrei soffermarmi sulla mia esperienza quotidiana al C.P.I.A, alle tante culture che incontro e alle fatiche di adulti che vivono qui ma non si sentono a casa.
Le signore e gli adulti che attraversano il centro sono persone in forte affanno, che hanno bisogno di concludere rapidamente i percorsi perché altrimenti non trovano lavoro. La richiesta che ci viene chiesto di soddisfare è più alta di quella di un tempo, si cerca l’accesso ad una cultura di livello maggiore rispetto a vent’anni fa. Alcuni studenti mi raccontano l’iter dei loro genitori: il papà è arrivato in Italia, faceva il muratore, ha fatto un anno di scuola, e ha trovato lavoro. Chiaramente questo non è più possibile. E l’insegnante si trova ad essere anche un filtro e ad avere una responsabilità nell’accompagnare la ricollocazione degli adulti.
Se immaginiamo di avere, come già accade, un medico proveniente dall’Algeria, ci aspettiamo non solo che sia competente, ma che abbia anche una competenza linguistica di un buon livello. Al contrario, immaginiamo noi in un altro paese: in Italia siamo professionisti affermati, contenti della nostra vita, se andiamo in un altro stato potremmo ritrovarci a fare le pulizie.
Anche qui Manzi da un insegnamento importante. Ripensiamo a quando insegna in carcere: ha messo da parte le cose, l’insegnamento standard e ha creato un’altra situazione.
Con gli adulti non riusciamo a raggiungere sempre l’obiettivo sperato, ma qualcosa davvero possiamo fare, dei piccoli passi. Tutti i giorni dobbiamo affrontare lo scoraggiamento, ma ci sono anche dei grandi successi. Pochi, o non quanti vorrei, ma ci sono.
Vorrei dedicare l’ultima parte del mio intervento ai ragazzi in forte difficoltà, stranieri e non. Questa è la parte del mio lavoro che preferisco, perché quando parlo di studenti minori si pensa sempre al ragazzino che è appena arrivato, in classe crea confusione oppure crea disastri, allora viene al C.P.I.A. Invece ci sono anche molti ragazzi italiani.
Questo mi spinge a riflettere e mi domando se il termine straniero sia davvero utile o se in realtà dobbiamo puntare la nostra attenzione sui bisogni e sulle necessità dei ragazzi, più che sulla provenienza; che provengano dal Marocco, dalla Tunisia, dal Senegal o dall’Italia, vivono la stessa grande difficoltà.
Chiudo tornando all’azione pedagogica: l’azione di presenza di un adulto nella vita di altri adulti e di altri minori è proiettata al futuro. La cura che mettiamo nel superamento di una serie di barriere è la garanzia della possibilità, non solo di integrazione degli altri, ma anche della costruzione delle identità di ognuno.
Potremmo fare una breve sintesi per tenere fermi alcuni punti:
- Futuro. Lavorare per il futuro di persone che si affidano a te per ricominciare, per cominciare in un altro modo.
- Il tema del conflitto, la gestione del conflitto all’interno della relazione. L’essere guida, ma con essenzialità. Quindi interrogandosi su quello che è essenziale per l’altra persona.
- Tutto per una missione: costruire, potenziare l’identità delle persone che a voi si affidano.