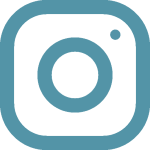– Maurizio Vitali –
L’alluvione in Romagna deve insegnarci qualcosa, suscitando in tutti una nuova consapevolezza di noi stessi e del territorio come bene comune. Nessuno può chiamarsi fuori.
Archiviare o imparare
Crisi ed eventi catastrofici possono avere due destini opposti: di essere presto archiviati nel dimenticatoio una volta passati, oppure di indurre a una salto di consapevolezza e di responsabilità. Questo accadde, per esempio, con l’alluvione della Valtellina nel 1987, dove l’esperienza dei soccorsi portò a riformare e potenziare la Protezione civile istituendo il Servizio nazionale e un dipartimento dedicato presso la presidenza del Consiglio. Furono anche stanziati 2.400 miliardi (di lire) per il riassetto idrogeologico, con buoni risultati.
Il passo avanti che questo (ennesimo) gravissimo cataclisma che ha colpito la Romagna dovrebbe favorire è di farci considerare il territorio come bene comune, non come semplice spazio a disposizione. Dall’assetto e dalla sicurezza del territorio dipendono tutte le attività umane. Viviamo immersi fino ai capelli in un modello di sviluppo che identifica il bene comune con il massimo possibile di consumi individuali: è ora di verificare se questa identificazione è valida o è una fregatura.
Chiamati in causa
Chiamata in causa è certamente la politica. L’urgenza dei problemi chiede di privilegiare il concorso a uno scopo comune sullo scontro a tutti i costi, cioè a dire il bene comune di lungo termine sul bene elettorale immediato. Non aiutano le cacce al colpevole, men che meno al colpevole unico: non solo perché la cosa non sarebbe, diciamo così, elegante, ma perché il colpevole unico non esiste e nemmeno esiste la causa unica. La realtà è complessa, e le semplificazioni manichee funzionano da sempre solo al bar; ora, ahimè, anche in certi talk show.
Chiamate in causa sono anche le istituzioni in quanto tali: nei momenti più drammatici si può sperimentare quanto sarebbe sempre necessario e fruttuoso il dialogo e la collaborazione tra i diversi livelli di governance per risolvere certi problemi, indipendentemente dal colore politico di chi ne è in quel momento a capo; così come il dialogo e la cooperazione delle istituzioni pubbliche con la società civile e il terzo settore.
Non si tratta certo di rinunciare alle proprie idee e alla propria identità, ma di provare a considerare – anche in politica e nella pubblica amministrazione – l’altro e la sua diversità come possibile arricchimento da recepire, e non come nemico da annullare.
Infine, chiamati in causa siamo tutti quanti. Innanzitutto gli scienziati: essi hanno la missione di fornire al decisore pubblico un quadro il più possibile oggettivo e credibile dei problemi e delle situazioni, mostrando di avere a cuore la verità e non il consenso. C’è da augurarsi che non si ripeta il penoso spettacolo di tanti “esperti di Covid” da piccolo schermo, a cominciare da quello che assicurava che non c’era pericolo perché “il virus non circola”.
Tra fango e domande
Ancora una volta nell’emergenza spunta fuori, come una bella sorpresa, l’altruismo: quello persino eroico di chi addirittura ha messo a repentaglio l’incolumità, o ha sacrificato propri beni per salvare altri; quello spontaneo e tenero nella sua quasi ingenuità di tanti ragazzi che hanno risposto ad appelli via social e – badile in mano e fango addosso dappertutto – mollano i rapper e si abbandonano al valzer di Casadei cantando Romagna mia.
Guardando questi ragazzi, vien proprio da pensare, con le parole antiche di Plutarco, “che sono fuochi da accendere, non vasi da riempire”, osservazione che vale non solo per la didattica ma per la vita. E il fuoco, se non lo accende qualcuno, può accenderlo la realtà, quando mostra senza veli o finzioni il bisogno umano, cui per natura non possiamo restare indifferenti. Quei ragazzi stanno facendo questa esperienza. Ora sarebbe un peccato se non trovassero in sé stessi, o nell’aiuto di qualcuno, il modo di rifletterci sopra e coglierne il senso profondo, che è innanzitutto quello di tirar fuori le grande domande che la consueta gaia o tristanzuola distratta banalità ci ammoscia fino a smorzare del tutto: perché c’è il dolore, perché il bisogno mi interpella e mi muove, che senso ha la vita, e perché un gesto di gratuità mi rende più contento?
È al livello di queste domande, cioè in sostanza del senso religioso, che gli uomini possono trovare la radice e l’alimento di una tensione all’unità, al dialogo e alla collaborazione non effimera e non per tornaconto, ma per il bene comune.
Fonte: Sussidiario.net