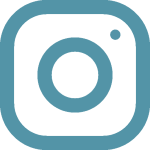Di Annalisa Teggi
“Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno”.
Gemma Calabresi racconta al figlio Mario come la fede le abbia fatto spezzare la catena dell’odio, facendola sentire libera e in pace.
Il 17 maggio del 1972 il commissario Luigi Calabresi fu ammazzato sotto casa da un commando di Lotta Continua. Stava recandosi in ufficio, lasciando dietro la porta di casa una giovanissima moglie incinta e due bambini piccoli.
A 49 anni da quei fatti il figlio del commissario Calabresi e sua madre si sono incontrati per parlare pubblicamente in un podcast di quella ferita sempre aperta nelle loro vite: il giornalista Mario Calabresi ha intervistato Gemma Capra Calabresi. Al centro del loro dialogo il tema più scabroso possibile. Si può perdonare degli assassini?
Ascolta il podcast
La memoria cammina nel presente
La settimana scorsa sono stati arrestati in Francia sette ex-terroristi, tra loro anche Giorgio Pietrostefani che fu riconosciuto come mandante insieme ad Adriano Sofri dell’omicidio Calabresi.
Questa svolta, che mette fine a una scandalosa latitanza durata 20 anni, ha portato Mario Calabresi ad anticipare l’uscita del podcast che da tempo desiderava fare, intervistare sua madre. Era stato pensato per commemorare la data del 17 maggio, ma l’incalzare degli eventi ha fatto sì che fosse giusto sentire quanto prima la voce di Gemma Calabresi.
Pietrostefani se la diede a gambe, fuggì dall’Italia per evitare il carcere. Ma c’è chi ha camminato molto di più in questi 49 anni anni e non per fuggire, bensì per dare un senso a una storia tragica eppure non disperata.
La memoria non è statica, ha le gambe. La memoria va portata nel presente, senza fermarsi a quel giorno.
GEMMA CALABRESI
Gemma Calabresi ha camminato, dal giorno in cui le ammazzarono il marito sotto casa. Erano entrambi giovanissimi, sposati da appena 3 anni e con 3 figli. Verrebbe da dire che avevano preso la rincorsa, pur essendo inconsapevoli che il loro tempo insieme sarebbe stato poco.
E che ne è stato, da allora, del tempo del dolore? 3 figli da crescere, gli occhi puntati addosso, un processo lungo come l’eternità da affrontare. Così Gemma racconta al figlio Mario gli anni che vennero dopo quel maggio del ’72:
Io ero indubbiamente triste. Ero incinta di Luigi ed è stato un periodo molto difficile … Riuscivamo comunque anche a ridere, questo sì. Io me lo ricordo, alla fine c’era vita comunque. Se tu ti ricordi, io ho scelto da subito di farvi vivere non nel rancore e nell’odio, ma ho fatto il possibile per darvi la gioia di vivere e di credere ancora nell’umanità, nell’uomo, nelle persone.
Ce l’abbiamo fatta
E’ bello il crescendo di parole nell’ultima frase: umanità, uomo, persone. La voce da astratta scende via via dentro il mondo incarnato. Non basta aver fiducia nell’umanità, occorre averla quando guardi negli occhi le persone che incontri.
Ed è proprio negli incontri umani accaduti in 49 anni di dolore e cammino che la signora Calabresi ha trovato la forza di non restringere il suo orizzonte al giorno più tragico della sua vita. Mario, un po’ da figlio e un po’ da giornalista, le chiede senza fronzoli: come ce l’hai fatta?
E lei risponde con un episodio esilarante.
Ce l’abbiamo fatta. Una mattina io sono andata a pagare una multa in centro e incontro una signora che mi dice: “Ma lei è….?” e io dico di sì. “Guardi, ero così arrabbiata a venire a pagare la multa di mio figlio, ma ecco perché è successo! Dovevo incontrare lei, adesso sono felice!” e mi ha abbracciata. Queste sono dimostrazioni di affetto che ti aiutano a vivere. Dico sempre: “Io non ce l’ho fatta, ce l’abbiamo fatta”.
Pochi uomini hanno distrutto la sua vita, ma molte persone l’hanno accompagnata a ricostruire una storia che non ha più l’odio come messa a fuoco di ogni sguardo. Raccontarsi al plurale è un segno bellissimo. E non è quella triste faccenda del parlare usando il plurale maiestatis, è invece riconoscere che non se ne viene fuori da soli dalle trappole, dai colpi duri, dalle tante tentazioni disperate che ogni giorno ci mette davanti.
I tanti segni di compagnia umana in cui Gemma Calabresi ha riconosciuto un sostegno indispensabile sono anche eco di un’altra compagnia che si è fatta strada con voce sempre più forte nella sua vita.
Tutto era già scritto nel necrologio
Quel giorno in cui hanno ammazzato mio marito io ho ricevuto il dono della fede. […] Io ho sentito veramente Dio vicino. Non mi sono sentita sola, mi sono sentita amata. Tutto il percorso del perdono viene da quel necrologio, ma per anni io non ci ho pensato.
A cosa si riferisce la signora Calabresi? Al necrologio che fu pubblicato sul Corriere della Sera all’indomani dell’omicidio di suo marito. Non fu lei a scriverlo, ma sua madre e scelse queste parole del Vangelo:
Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. – Lc 23, 34
E’ la voce di Gesù in Croce. Ed è questa voce a dare una svolta a tutto. Inizialmente quel necrologio sembrò giusto a Gemma come slogan forte da contrapporre agli slogan di odio e rancore che ammorbavano quegli anni di piombo.
C’era invece una chiamata precisa, personale, da scoprire ed è maturata con il tempo. La signora Calabresi ha insegnato religione alle elementari per tanti anni. Il rapporto coi bambini era bellissimo, loro la adoravano. Eppure lei, in cuor suo, sentiva di tradirli: insegnava il perdono evangelico, ma non ne faceva esperienza nella sua vita.
Nessuno si sentirebbe di biasimarla, come si fa a perdonare degli assassini? Ed è proprio questo il punto. Non è un dovere, non è uno sforzo e non è neppure un gesto.
Lascio che siano le parole di Gemma Calabresi a dire cosa abbia pian piano scoperto riguardo al perdono:
Sono passati anni, a un certo punto mi sono detta: quella frase sul necrologio che ho firmato è giunto il momento di farla mia. E allora mi sono messa ad analizzarla: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. E immediatamente l’ho letta diversamente. Ma perché Gesù, figlio di Dio, non ha detto direttamente: “Vi perdono”?
Perché in quel momento Gesù era uomo e quindi come uomo si rendeva conto che noi uomini nel momento dell’abbandono, del tradimento, della solitudine, della calunnia, del dolore fisico e morale, non saremmo mai riusciti a perdonare. E quindi chiede al Padre di farlo lui al posto nostro, lasciando a noi il tempo del cammino. A quel punto mi sono sentita come liberata, leggera. Ho pensato: Lui lo ha già fatto per me, al posto mio, e quindi io ora ho il tempo del cammino e non sarò sola a farlo.
Desta sempre grande stupore quando ci si accorge che il Vangelo “accade” nel momento in cui le sue parole s’incarnano nella nostra vita. Non avevo mai sentito un’ipotesi simile sul perdono. Ed è qualcosa di davvero liberante, perché ci toglie dalla trappola di pensare che sia una nostra capacità, da conquistare con sudore e lacrime.
Non siamo stati messi su un ring in cui conta l’allenamento fatto, la resistenza ad incassare colpi, la forza per picchiare più duro. Siamo invece in cammino, e Chi detta il passo ha già sconfitto le nostre tenebre più cupe.
Fonte: Aleteia