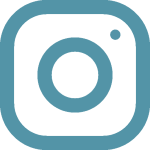Di Johnny Dotti
Questa breve riflessione nasce da una prima lettura e meditazione della terza enciclica di Papa Francesco “ Fratelli tutti” sulla fraternita e l’amicizia sociale.
Lettura che si intreccia e tiene conto delle due precedenti encicliche: ”Evangelii gaudium” e “Laudato si”, che il Papa ci ha regalato in questi 8 anni.
Centralità del Vangelo, amore per il creato, fraternita universale. Un vero percorso di senso quello proposto da Papa Francesco. Il senso del nome che si é dato.
La riproposizione, attualizzazione, rigenerazione dell’esperienza evangelica di San Francesco. Una precisa ispirazione. Una profonda ermeneutica evangelica dunque.
La lettura di questo testo non può poi non risentire del contesto in cui stiamo vivendo.
La grande crisi pandemica mondiale in cui siamo, da un anno quotidianamente immersi e con una prospettiva un po’più ampia questo primo ventennio del terzo millennio.
Questa enciclica, in continuità con le due precedenti, ci interpella, ci convoca ad una trasformazione.
Si avverte leggendola l’urgenza di un cambiamento paradigmatico, la sollecitazione ad intraprendere strade nuove, che alla luce del Vangelo possano portare nella nostra vita, nel nostro “qui ed ora” una luce di speranza e di possibilità di trasfigurazione delle nostre esistenze. Non un semplice cambiamento di forma, ma una profonda consonanza tra interiorità ed esteriorità, tra contemplazione ed azione.
Se in Evangelii gaudium l’invito e la sollecitudine si concentra sulla proposta di vivere integralmente l’annuncio gioioso del Vangelo ( una riattualizzazione del “sine glossa” francescano) accogliendone il dono di una vita piena, da-con-per-in Cristo.
E se il Laudato si, con toni anche drammatici e moderni ci veniva ricordato che “ tutto è collegato a tutto” e che c’è una profonda armonia con il creato, madre terra, che ci è chiesto di riconoscere, lodare e custodire, non di depredare e distruggere ( eco del Cantico dei Cantici di San Francesco).
In questa terza enciclica l’accento è posto sull’essere fratelli, sull’essere fratelli e sorelle di tutti, con tutti e per tutti. Così San Francesco viveva il rapporto con gli altri, con tutti gli altri vicini e lontani. Così viveva il rapporto con le creature, con il cosmo, persino con la morte.
Un atteggiamento profondo, una epifania della sua esperienza di Dio, un modo semplice e impegnativo per vivere in pienezza la gioia evangelica dell’incontro con Cristo. Vera pietra di scandalo e di inciampo per il suo tempo, per tutti tempi. Perchè questa tensione generativa alla fraternità rende necessari povertà, umiltà e minorità
E oggi? E noi?
Travolti come siamo dalla nostra volontà di potenza, dal mito individualista, scientista, sviluppista e funzionalista. Obnubilati dalla fantasia perversa della massimizzazione e della competizione assoluta. Quale ortoprassi può rendere viva l’ortodossia? Quali esperienze sono in grado di rigenerare le istituzioni? Quale comunità può far da lievito a tutta la società? Da dove cominciare?
Le tre grandi crisi che hanno in particolare messo in discussione gli orizzonti del mondo occidentale negli ultimi vent’anni ci chiedono una conversione, una trasformazione. Ci chiedono un giudizio su noi stessi.
La distruzione delle torri gemelle nel 2001 e la conseguente diffusione mondiale del terrorismo, il crack finanziario del 2008 e la crisi mondiale che ne è seguita, l’attuale pandemia in cui siamo immersi tutti nel mondo, Chiedono di non continuare indifferenti per la nostra strada, non è possibile dire semplicemente come si sta tutt’ora facendo: “ripartiremo”.
Non si può rimanere indifferenti alla distruzione del creato (che è anche autodistruzione umana), alle ingiustizie economiche e politiche evidenti nel mondo. Ripartire significa semplicemente rimuovere ciò che queste crisi ci stanno con forza dicendo. Far finta di niente. Destinare le generazioni future a disastri inauditi. Non si può non avvertire la necessità di riportare in un orizzonte di senso l’enorme sviluppo materiale conquistato in particolare in occidente. Fermarci, usare intelligentemente il pensiero critico. Convertirci. Trasformarci.
Certamente la fraternità e l’amicizia sociale sono una via, esperienziale e istituzionale, per riscoprire il nostro essere persone, nodo di relazioni, e non banali individui, monadi separate dagli altri e dal mondo. La fraternità invita a vivere una spiritualità incarnata e non astratta, a ritrovare una vocazione concreta, in grado di dar vita ad una crescita integrale: intellettuale, corporea e spirituale. La fraternità ci fa sentire “pars pro toto” non semplicemente “pars in toto”, aiutandoci a non finire in derive tecnico funzionaliste alienanti e distruttive.
Fratelli cioè figli e creature. Figli e creature amate. C’è quindi una via tradizionale per vivere, riscoprire e rigenerare il nostro essere fratelli: Condividere.
Condividere quello che siamo e che abbiamo, superare un idea mortifera di possesso, vivere la proprietà come una responsabilità e non un esclusività. Giocare il gioco della libertà con una visione radicale di relazione. Fonte di ogni gioia.
Non solo la nostra vocazione di persone ontologica ed ontonomica chiede fraternità ma oggi urgentemente lo chiede questo tempo e la sua necessità di trasformazione.
Possiamo trasformarci dunque in fratelli e sorelle se sapremo condividere. Se ci alleneremo costantemente, in atteggiamenti e comportamenti, a condividere. Così forse avremo la grazia di vivere la fraternità.
Andiamo verso una situazione che rischia di essere connotata da : verticalizzazione, con tutti i rischi di autoritarismo che porta con sé; tecnocrazia ,con tutti i rischi di alienazione; separazione ,con tutti i rischi di nichilismo e emarginazione. Ma questa se la sappiamo vivere profondamente è anche uno straordinario trauma trasformativo. Allora sono da alimentare: Autorità, che è l’arte di far crescere; tecnocultura, dove il perché viene prima del come; distinzione e non separazione, perchè l’identità è una relazione.
Il tempo e il luogo per questa alimentazione è la comunità. A cominciare dalla comunità ecclesiale. Non c’è uomo senza comunità. Non c’è società senza comunità.
La comunità si genera ( cioè si desidera, si mette al mondo, ce ne si prende cura, si trasforma) nella condivisione.
Condividere la domanda porta al senso, condividere il senso porta al consenso. Condividere la fragilità porta alla solidarietà, condividere la responsabilità porta alla libertà, condividere i bisogni e i desideri porta alla politica e ad una nuova economia. Condividere i talenti porta al valore, condividere i propri spazi porta all’ospitalità, condividere il proprio tempo porta all’eternità, condividere il dono è perdonare.
Così : condividere pensieri e parole è dialogare, condividere aspirazioni è sperare, condividere esperienze è narrare, condividere il proprio io è riconoscere che siamo un tu, condividere il noi è riconoscere il voi, condividere il sogno è generare nuovi mondi, condividere il silenzio è pregare insieme.
Perciò vanno autorizzate tutte le esperienze che desiderano e vanno in questa direzione. Promuovendole, accompagnandole, curandole, raccontandole. Mettendole in connessione tra loro. La sfida è una libertà, per tutti, più adulta e consapevole. Non c’è Fraternità senza libertà. La fraternità non deriva da una legge, ma dall’amore. Servono esperienze comunitarie concrete di condivisione : materiali, digitali, territoriali, intellettuali, lavorative, economiche, finanziarie, culturali, spirituali, ecologiche,politiche.
Queste sono esperienze istituenti. Vivono il presente e alimentano le istituzioni, aprono la via a forme istituzionali nuove , nel campo politico, economico, sociale ed educativo ad esempio. Solo cosi’, dal basso e insieme, si può e si deve sperare di transitare verso forme più giuste e vere di vita.
Solo condividendo si moltiplica il necessario. Ne avanza pure. Solo condividendo si fa esperienza di fraternità. Di fraternità con tutti. Si fa esperienza di Dio.
Sull’abitare
Habitare è verbo intensivo di habere . L’intensivo è un verbo che sottolinea l’energia dell’azione. Habeo sta per avere indosso, tenere, portare, avere in se, contenere, nutrire, possedere, avere in potere, sapere, conoscere, tollerare, sopportare, dare, offrire, avere con se, abitare, dimorare, passare il tempo trascorrere. E’ l’abitare che crea l’habitus ( abito, modo di essere, forma, atteggiamento, conformazione dell’animo ) e costituisce il contesto in cui si sviluppa l’ethos, la norma di vita di una persona e di una comunità.
Cercherò di sottolineare l’importanza degli atteggiamenti che sostengono sul lungo periodo i comportamenti, ma anche dei comportamenti che allenano e sviluppano gli atteggiamenti. Perché l’abitare è la disposizione concreta che nell’esistenza ci fa coniugare corpo, anima e spirito. Così abitare un luogo non è semplice stare (casomai è star-ci), appoggiarsi, occupare uno spazio e un tempo.
Abitare è conoscere, gustare, curare, coltivare, trasformare, costruire, farsi innanzi tutto abitare da quel luogo, da quello spazio, da quel tempo. Mettersi in sintonia. Abitare è trasformarsi. Abitare è relazione. Simbolo e significato. Per questo abitare è felicità e gioia ma contestualmente fatica e sacrificio. È, comunque sia, condividere un posto, con gli altri e con il nulla.
C’è dunque da portare un contributo all’abitare oggi. Noi oggi dobbiamo portarlo. Lo chiede la nostra storia. Ce lo chiede questo tempo. Perché abitare è non sottrarsi alla realtà e non far sottrarre alla realtà contingente un posto fondamentale di felicità per ogni uomo comune. Non c’è bene comune se non sorge dall’uomo comune.
Se non si abita la vita , si finisce nel “luogo comune”, nel pregiudizio, nello stereotipo. Ci si disumanizza. È questa tensione che invece ci rende degli esseri umani. E siamo noi, uomini e donne comuni che, sappiamo, dobbiamo costruire e abitare questi luoghi. C’è una profondità infinita in ogni quotidiano, che può essere colta nella sua inquietante angoscia così come nella sua tenera bellezza.
E’ perciò necessario sostare, educare e curare questa nostra dimensione.
Appartamenti?
L’alloggio non è la casa. Perché dico questo? Perché su questo va incardinato un pensiero tradizionale nuovo dell’abitare. L’abitare è la modalità di esistere dell’essere; senza l’abitare non c’è l’essere. L’uomo è esistente (ex-sistere: stare fuori). Produce forme come il vestito e come la casa: le forme sociali sono tutte forme dell’abitare. Però l’abitare noi lo abbiamo in gran parte ridotto a funzione, l’abbiamo svuotato di esistenza.
Noi abbiamo una grande tradizione riguardo alle forme abitative che abbiamo abbandonato troppo alla svelta. Bisogna ritornare all’idea trinitaria dell’«e… e», non più «o… o». Va benissimo la mega-postazione tecnologica da dove ti puoi connettere con il mondo, ma ti serve anche quell’esperienza primaria non codificata dove le persone si possono scambiare due parole senza per forza stare dentro a un progetto educativo, a un progetto sociale, a un progetto… di qualsiasi tipo. Tutto l’abitare invece è finito solo dentro alla progettazione. Non solo progettare, invece: si tratta di tornare a liberare la libertà, che è una dimensione invisibile ed è una dimensione infinita, che a volte possiamo, come dire, accarezzare, ma non immaginare di incanalare dentro processi di azione.
Credo che l’esperienza che stiamo facendo del vuoto, in questo tempo del coronavirus, ci porti a ridefinire anche tante cose del pieno. Vuoto, però, non solo come spazio vuoto, ma anche come tempo. Forse questo è anche il tempo di andare al di là del tempo, come l’ho chiamato sopra, lineare.
Noi invece sinora abbiamo giocato a riempire tutto. Il consumo compulsivo cui siamo stati allenati negli ultimi cinquant’anni non è stato altro che una grande fuga dal vuoto. Noi il vuoto non lo reggiamo. Abbiamo bisogno di riempirlo costantemente. Questo tempo presente ci chiede invece di attraversarlo, di farcene attraversare. Le forme sociali, le forme umane, le forme affettive nascono tutte dal vuoto. Il desiderio non si accende se non c’è il vuoto. Le stelle non riesco a vederle se c’è di mezzo il fumo, devo avere un cielo sgombro, devo essere al buio. Questo dice tante cose: sui tempi del lavoro, sui tempi del riposo, sui tempi della meditazione, sui tempi che non sempre devono essere vissuti di corsa, accelerati. Ogni tanto bisogna andare più lenti.
Vuoto, silenzio e solitudine sono forme dell’«abitare». Se vivi in un «alloggio» è evidente che non puoi vivere nel vuoto, nel silenzio, nella solitudine: impazzisci. «Alloggio» è una parola che abbiamo preso e applicato artificialmente alle case per gli uomini. Fino a un secolo fa si usava per i soldati e per gli animali. Non ci può essere un «alloggio» per una famiglia. Ci deve essere una «casa», che contempli spazi, relazioni, che contempli un dentro e un fuori. Lo stesso vale per il termine «appartamento», che viene dalla tradizione imperiale portoghese e francese. Ma gli appartamenti in quel caso stavano dentro le regge. La casa invece non è un appartamento e non è un alloggio: è il luogo e il tempo in cui le nostre relazioni fioriscono perché sono custodite come in un nido, e crescono perché vengono messe dentro una rete. Perché la casa, come la famiglia, è contemporaneamente un nido e una rete.
Noi veniamo dall’epoca degli appartamenti: sarebbe meglio dimenticarsene. Tra l’altro è l’epoca degli appartamenti che ha generato la bolla speculativa del 2008, perché la bolla è stata fatta esattamente sul mito della casa ridotta ad appartamento – appartamento vuol dire separazione. Mettiamoci allora a ricostruire forme di vita un po’ più comunitaria. Perché ognuno di noi immagina di essere più libero dentro una casa con otto telecamere, la porta blindata, senza conoscere il vicino? Ripensare il rapporto tra generazioni vuol dire ripensare anche le forme dell’abitare. Partendo da dove? Dalla nostra fragilità. La non autosufficienza non è affrontabile se non avremo nuove forme dell’abitare. E questa è economia, un’enorme economia. Ricordiamoci che sull’edilizia sta in piedi la maggior parte dell’economia del mondo, compresa quella cinese – che adesso è dentro il mito dell’appartamento: si stanno innalzando grattacieli con casette da 30 metri quadrati dove ognuno morirà solo.
Cominciamo a sperimentare. Un anziano che vive solo in una casa di 80 metri quadrati a Milano – ce ne sono tantissimi – e uno studente che paga 400 euro per un letto da sfigato, in nero, da qualche parte, per stare all’università si possono connettere? Sì. Faccio contemporaneamente un’operazione di assistenza, di compagnia, di riqualificazione di un immobile, di generazione di servizi… Faccio un’impresa attraverso la riconnessione di due vite, ripensando le forme di vita. Posso immaginare che la famosa badante solitaria – oggi ognuno ha la propria badante in silenzio, se la tiene stretta per il papà e per la mamma – la possa condividere? E che allora in un palazzo c’è una sola badante per tutti? E magari facciamo anche una lavanderia per tutti. Facciamo un piccolo spazio per i bambini, per tutti. Invece noi veniamo da un Novecento dove il caposcala doveva mediare le liti tra i “vicini”
I nostri paesi, un tempo, erano costruiti rispondendo a questo concetto: la piazza, i vicini, le case di ringhiera, le cascine… Sto dicendo cose assolutamente «tradizionali». Ma non hanno a che fare con l’antiquariato, hanno a che fare con la trasmissione di un principio. Ora noi dobbiamo consegnare questi principi, trasformati, alle nuove generazioni. Ma senza interiorità non riusciremo a farlo.
Sulla comunità
“Comunità” è una di quelle parole che possono fare molto male o che possono aprire orizzonti inesplorati: noi siamo comunità. La comunità non è nient’altro che l’esperienza umana della nostra componente plurale. In quanto persone, noi non siamo né singolari né plurali e siamo contemporaneamente singolari e plurali.
Come insegnano tutte le lingue del mondo – Io, Tu, Egli o Ella sono prima, seconda e terza persona singolare; Noi, Voi, Essi sono prima, seconda e terza persona plurale. Facciamo l’esperienza di essere un Noi in quanto persona. Detto in tempi di crisi dal punto di vista individualista, appare una cosa un po’ strana: continuano a spiegarci che siamo il nostro Io, ma l’Io è un sesto della persona, tra l’altro un terzo dell’esperienza singolare, mentre la principale esperienza che facciamo come persona dal punto di vista singolare è di essere un Tu di qualcuno – il tu di un amante, il tu di un amico, il tu di un figlio, il tu di un altro. Questa è l’esperienza esistenziale più evidente, finiremmo in ragionamenti totalmente astratti se volessimo descrivere separatamente l’esperienza dell’Io.
L’esperienza esistenziale più concreta è quella del Tu, il principio singolare che ci conduce all’esperienza plurale di Noi. Questo è fondamentale dal punto di vista antropologico, filosofico, spirituale, sociologico, mentre siamo radicati nell’immaginario di noi stessi come individui. Io contesto radicalmente questa definizione di uomo: un uomo non è, non esiste come un individuo. Dal punto di vista dell’esperienza esistenziale, è una persona.
Dal nostro sentirci individui sono nati gli alloggi, gli appartamenti, che sono esattamente la forma opposta e ci portano a stare male. Ecco, dunque: noi siamo comunità. Non in modo esclusivo, ma la comunità è l’esperienza plurale di noi.
Siamo comunità, non abbiamo una comunità. La comunità sta dentro di noi, non fuori di noi. Non siamo banali e alieni individui, monadi assolute nel tempo e nello spazio. L’individuo è un astrazione. La persona è un essere esistente in relazione, anzi per meglio dire una “mancanza d’essere” esistente in relazione. Nodo di relazioni che la precedono, la superano nel tempo, la trascendono. La propria unicità, mistero costitutivo di ogni persona, dona e chiede libertà. Libertà che è un legame di senso con il tutto.Perciò libertà è sempre comunità, la “mia” libertà e sempre la libertà “ dell’altro”. Noi, voi, essi, sono la componente plurale della persona. La relazione di questi pronomi genera la comunità. Così come l’io assoluto è una illusione patologica della persona singolare, ma esiste sempre un io in relazione ad un tu ed ad un egli/ella, così il noi assoluto produce altrettanto danno. Un “noi psicotico” è molto più dannoso di un “io narciso”. Come drammaticamente insegnano tante tragedie di famiglie, popoli, ma anche di organizzazioni, nella storia umana. Comunità non è immunità.
La comunità non è mai data definitivamente, è sempre in cammino, pellegrina nello spazio e nel tempo, vive di incontri, si nutre e si rigenera nelle relazioni. Respira il respiro della coscienza della nostra libertà. In questi tempi di apocalisse, rivelazione della realtà, dovremmo annunciare a tutti che non c’è società senza comunità, non c’è organizzazione senza organismo. Non è un problema di dimensione, siamo tutti “pars pro toto”, è una opportunità di senso che ci regala nel dramma la possibilità, donata alla nostra libertà, di essere migliori. Insieme.
Beni in comune. Un nuovo spazio ed un nuovo tempo per la politica e l’economia
I beni in comune sono stati dall’unità d’Italia in poi considerati “ pubblici” ( nel senso ristretto di Statali). Movimento politico, probabilmente necessario, per garantirne l’accesso a tutti e togliere ingiusti privilegi. Nel tempo questo movimento ha mostrato la corda sia sul versante della esigibilità, che su quello della economicità a soprattutto sulla capacita’ di riprodurre il significato e valore di ciò che “ appartiene a tutti”.
Ci siamo così trovati a considerare questi beni solo come un costo e non nella loro più complessiva forma di valore. Si e’in molti casi spesso passati dalla loro pubblicizzazione alla loro privatizzazione. Stravolgendone il senso ed inserendo nuovi problemi.
Ha particolarmente senso parlare in Italia di beni di comunità perché l’Italia quando funzione e’ una armonia di centinaia di territori diversi ed esattamente all’opposto quando non funziona e’ una frantumazione infinita di interessi contrastanti. Trovare il giusto assetto significa innescare un dinamismo virtuoso.
Vivere in comunità… Ma questo vale anche su più larga scala, poiché non c’è società senza comunità. Negli ultimi anni si è fatta confusione tra beni pubblici e beni comuni. I beni comuni non sono beni pubblici.
Dire che la nostra vita è legata a quella degli altri non vuol dire tornare a immaginare uno stato alla Hobbes, che impone le proprie leggi a tutti con la forza e la violenza. Significa fare un passo avanti in senso democratico. I beni comuni – il welfare, i trasporti, l’energia, la sanità, la scuola… – sono beni di tutti. Le forme per dar loro vita, perché tutti ne partecipino, non sono per forza la fiscalità generale, la burocrazia, le leggi. Sono anche forme di autorganizzazione, di autolimitazione del profitto, di generazione e distribuzione del valore dentro la libertà. Guardiamo la scuola: tornerà a essere identificata con un edificio chiuso in cui accadono delle cose, o l’inevitabile apertura di queste settimane porterà a un suo cambiamento vero?
Noi veniamo da un Novecento dove i beni comuni hanno avuto questa sorte: sono stati prima presi dallo stato, col risultato che lo stato non ce la faceva, e poi cosa succedeva? Si privatizzava. I beni comuni sono oggi, per me, il più grande terreno di generazione di occupazione e di nuova forma di economia in Italia. «Ma cosa vuoi dire: privatizziamo tutto?». No! Non c’è solo il privato e il pubblico: c’è il comune. Tra l’altro, la tradizione civica italiana è «comune», che non vuol dire municipio ma costruzione di unicità particolari, perché chi vive lì si sente al centro del mondo. Questa è l’Italia che ha fatto cento città diverse. Questo bisogna rimettere al centro e farlo diventare una questione fondamentale dal punto vista democratico, perché gestendo l’acqua in comune costruiamo nuove forme di partecipazione – oltre al voto, alla fiscalità e alla pubblica amministrazione. Costruiamo forme secondo le quali di un bene io sono responsabile e faccio in modo che quel bene sia per tutti.
Fonte: generativita