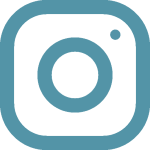di suor Cristina Merli, FMA
2^ PUNTATA – Educare alla cura
Nei momenti di crisi, se ci si lascia toccare da ciò che accade, si diventa più essenziali, si scopre ciò che è indispensabile e si impara a lasciar andare ciò che è accessorio. Rubo il titolo di una bella canzone di Simone Cristicchi, “Le poche cose che contano”, per riflettere su quali sono le parole che oggi veramente dobbiamo salvare in educazione. Ogni genitore, docente, educatore potrebbe fare lo stesso esercizio e magari qualcuno lo ha già fatto. Io ho scelto quattro espressioni, per quattro puntate.
Custodire la FRAGILITÀ
Educare alla CURA
Esercitare la/alla COMPASSIONE
Vivere la SPERANZA
EDUCARE ALLA CURA
Una delle parole più pronunciate da un po’ di mesi a questa parte è “cura”: cura dei malati nei reparti degli ospedali, in terapia intensiva, nelle case, nelle RSA, cura dei figli a casa da scuola per casi di positività nelle loro classi, cura dei nonni non andando a trovarli ma facendo videochiamate, cura dei bambini e degli adolescenti attraverso la creatività di docenti che si sono inventati, con la Didattica a Distanza, qualcosa di bello. “Recovery”, poi, è una parola che sentiamo fino allo sfinimento, e anch’essa ha, tra le sue traduzioni italiane, l’accezione di “cura”.
Cosa avremmo fatto in questi mesi senza tante persone che si sono dedicate agli altri?
La realtà ci dice che la “cura” è dunque un elemento indispensabile, è una delle poche cose che contano in questi tempi per i singoli, per le famiglie, per la società, per la terra malata.
Dobbiamo allora educare i nostri bambini e i nostri ragazzi ad avere cura, a partire dalle piccole cose: avere cura della propria cameretta, dei propri giochi (ne hanno talmente tanti che capiscono che non importa se li rompono o li perdono, tanto poi ne arrivano subito altri), cura di una piantina verde, perché riesca a vivere grazie anche a me, cura di un cagnolino, di un gattino, di un canarino, cura della sorellina o del fratellino, del compagno di banco che fa più fatica ad apprendere, di quello che è più lasciato solo, del nonno che aspetta una telefonata dai nipoti, cura della natura, imparando quei piccoli gesti quotidiani che ci aiutano a non inquinarla, perché è lei che ci permette di vivere.
Durante il lockdown, un caro amico di un paesino in provincia di Bergamo si è ammalato di Covid, contagiato da sua moglie, medico, malata gravemente anche lei. Sono rimasti a casa, perché in ospedale non c’erano posti. I loro tre figli adolescenti facevano la spesa, cucinavano, pulivano la casa, accudivano e curavano in tutto e per tutto i loro genitori. Si improvvisa un comportamento così? Non credo, lo si impara, lo si coltiva nel quotidiano, guardando qualcuno più grande che lo fa. E basta.
C’è bisogno della cura per poter vivere, c’è bisogno di decentrarsi, di uscire da noi, di fare come il Papa ripete in continuazione e come ha messo nero su bianco nella sua ultima enciclica, Fratelli Tutti: passare dall’”io” al “noi”. C’è bisogno di prendersi a cuore qualcosa, qualcuno per essere felici, non perché sia moralmente corretto, ma perché è l’unica strada della felicità.
Per Don Bosco l’educazione alla cura dell’altro era pilastro dell’esperienza educativa.
Ne troviamo un esempio nella biografia di un ragazzo scritta dallo stesso Don Bosco. Il ragazzo si chiama Michele Magone, incontrato un tardo pomeriggio di una giornata nebbiosa d’inverno alla stazione ferroviaria di Carmagnola. Oggi definiremmo Michele un “ragazzo difficile”. Don Bosco riesce a farlo andare all’oratorio.
Era sua abitudine affiancare ai nuovi arrivati un compagno che già da tempo viveva a Valdocco. Così fa con Michele.
Scrive Don Bosco:
“Per prima cosa gli venne affiancato un compagno che a lui facesse da Angelo custode. Senza che Magone lo sapesse, nel modo più accorto e più caritatevole quel compagno non lo perdeva mai di vista; lo accompagnava nella scuola, nello studio, nella ricreazione: scherzava con lui, giocava con lui. Ma ad ogni momento bisognava che dicesse: non fare questo discorso che è cattivo; non dire quella parola; non nominare il nome santo di Dio invano”.
Dopo un mese di permanenza all’Oratorio Michele comincia ad essere pensieroso, a volte malinconico. Il suo “Angelo custode” lo aiuta a trovare le ragioni del suo stato d’animo.
“ – Mio caro Magone, da qualche giorno io non vedo più nel tuo volto la solita allegria; sei forse malato?
- No, di salute sto benissimo.
- Da dove dunque deriva questa malinconia?
- Questa malinconia deriva dal vedere i miei compagni prendere parte alle preghiere, nelle quali io non credo. Quel vederli allegri, pregare, accostarsi alla Confessione, alla Comunione mi provoca continua tristezza.
- Non capisco come la fede degli altri possa esserti oggetto di malinconia.
- La ragione è facile a capirsi: i miei compagni, che sono già buoni, praticano la religione e si fanno ancora più buoni; ed io che sono un birbante non posso prendervi parte, e questo mi provoca grave rimorso e grande inquietudine.
- Oh ragazzo che sei, Se ti provoca invidia la felicità dei compagni, chi ti impedisce di seguirne l’esempio? Se hai rimorsi sulla coscienza non puoi forse levarteli?
- Levarteli…levarteli… presto detto! Ma se tu fossi nei miei panni…”
Interverrà poi lo stesso Don Bosco a guarire la malinconia di Michele.
Ecco, il Padre dei giovani agiva così, nella semplicità: educava i suoi ragazzi alla cura, li invitava all’attenzione fattiva all’altro, li esercitava a passare dall’io al noi.
E li rendeva felici.
Facciamo come lui, senza moralismi, ma con la consapevolezza che questa è l’unica strada della Vita.
E li renderemo felici.