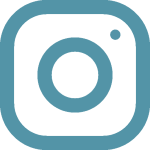Di Mauro Magatti e Chiara Giaccardi
La risposta alla pandemia del Covid-19 — una reazione pressoché mondiale, pur con qualche significativa eccezione — è stata il lockdown. Abbiamo fatto la cosa migliore? C’è chi dice sì e c’è chi dice no. Però, la domanda giusta è un’altra. Per quanto tempo avremmo potuto rinunciare alla libertà e consegnarci alla sorveglianza totale? Poco, molto poco, perché la libertà non è la volontà di potenza di un individuo, di una cultura, di uno Stato, ma la stessa condizione umana nella quale nasciamo, viviamo e moriamo e senza la quale non siamo in grado di ottenere nemmeno quel poco di sicurezza di cui abbiamo bisogno per vivere in modo decente.
Allora, l’esperienza catastrofica dell’epidemia, letta in questo modo, non è solo un male da cui difendersi, ma diventa anche, per dirla con l’espressione che Ernesto De Martino usa nel libro La fine del mondo, una «catastrofe vitale» che ci spinge a ripensare noi stessi e, insieme, il mondo vecchio che tramonta e il mondo nuovo che sorge, perché la fine a volte è un inizio. È proprio questa l’interpretazione che Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, con il libro: Nella fine è l’inizio. In che mondo vivremo (il Mulino), danno dell’esperienza distopica e dispotica che abbiamo vissuto.
Gli uomini dinanzi ad un trauma reagiscono in due modi: o rimuovono o rinascono. La prima reazione è un meccanismo di difesa: dimenticare e riprendere a vivere come se nulla fosse accaduto. Ma c’è un ma: dimenticare senza capire ci espone alla possibilità di commettere gli stessi errori. E siccome nessuno vuole ripetere l’esperienza, «che nel pensier rinova la paura» come dice Dante, dell’epidemia e della chiusura totale, non resta altro da fare che, per seguire ancora il padre della nostra lingua, rinascere a «vita nova». Per farlo è giocoforza assumere su di sé proprio la vita che si cela nella stessa catastrofe. Se c’è una cosa che rivelano sia il contagio sia la chiusura è che la vita umana è prima di tutto relazione e che, lo si voglia o no, la relazione riguarda sia il male (l’infezione) sia il bene (la libertà).
La nostra società è «descritta» dagli autori — entrambi insegnano Sociologia alla Cattolica di Milano — attraverso cinque concetti: rischio, connessione, libertà, potenza, insicurezza. Non sono parole vuote, ma condizioni reali che hanno dentro di sé sia il bene sia il male. Con il sopraggiungere di un evento imprevisto come la pandemia il rischio può diventare emergenza, la connessione isolamento, la libertà sorveglianza, la potenza fragilità, l’insicurezza angoscia. Sta a noi fare in modo che l’ambivalenza non degeneri verso il male, ma sia invece occasione di nuova creazione di bene, non dando risposte vecchie a problemi vecchi bensì risposte nuove a problemi nuovi. Facile a dirsi, difficile a farsi, naturalmente.
Infatti, gli autori si guardano bene dal fornire soluzioni astratte e danno, invece, delle risposte aperte che corrispondono a: resilienza, interdipendenza, responsività, cura, pro-tensione. Lo fanno, in verità, anche con una certa ironia, perché si rendono conto del limite stesso delle parole, come ad esempio «resilienza» che, per il troppo uso, rischia di richiamare una sorta di resistenza alla retorica della resilienza.
Tuttavia, la questione è proprio ciò che si è detto: non ci sono soluzioni pratiche, che ognuno dovrà trovare provando, ma interpretazioni per mettersi alla pari con il «nuovo mondo». L’abusata immagine della «macchina che deve ripartire» è a sua volta una formula retorica che non funziona e finisce per condurre la macchina fuori strada perché la società, e in generale la vita umana, non è una macchina.
L’unico modo per tornare indietro è andare avanti cercando di non ripetere gli errori precedenti. È come se l’epidemia avesse mostrato i limiti della società che, sottovalutati, si sono capovolti. Abbiamo ignorato i rischi fino a trasformare la realtà in irrealtà e le cose concrete si son riprese i loro diritti. Abbiamo creduto possibile che miliardi di persone potessero vivere come monadi in un mondo illimitato e il mondo ha capovolto l’utopia in distopia. Perfino la libertà è stata messa sul banco degli imputati e si è pensato, come in passato, che per conservarla andasse messa per un po’ tra parentesi.
Un errore che, se ripetuto con nuove crisi, ci condurrebbe verso la «società della sorveglianza». È questo il nostro destino? Per evitare «la fine del mondo» non possiamo fare altro che ripensare la libertà. A conti fatti, la cosa più antica del mondo.
Dopo i momenti critici è un errore pensare di ricominciare come se nulla fosse accaduto.
Fonte: Generativita