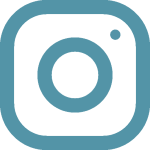Alda Merini

«PER ME LA VITA È STATA BELLA PERCHÉ L’HO PAGATA CARA»
“La pazza della porta accanto” che intingeva il calamaio nel cielo.
A dieci anni dalla morte, ritratto della poetessa milanese. I versi, la malattia, la potenza della vita.
E «il primo bacio di Gesù»
di Silvia Guidi per Tracce
«Composizione / atroce: la mia mente che / è andata / a pezzi / sul mio parabrezza infinito».
I versi di Alda Merini, scomparsa il primo novembre di dieci anni fa, vengono copiati, postati e condivisi sui social network. La pazza della porta accanto, l’habitué del caffè Chimera, come definiva se stessa, è sempre più conosciuta, sempre più citata, anche nel mondo digitale.
Google le ha dedicato un doodle il giorno del suo 85esimo compleanno: Alda tiene tra le braccia uno dei suoi libri e ha alle spalle un ponte stilizzato, che idealmente richiama quelli dei Navigli di Milano, zona in cui ha abitato per anni. «Sono nata il ventuno a primavera ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle potesse scatenar tempesta», dice di se stessa.
Ma la follia, dimensione a cui viene associata, per Alda Merini non è solo una metafora letteraria. È anche un’esperienza concreta, quotidiana, penosa, un pozzo di angoscia da cui risorgere ogni volta più ferita ma più forte, più consapevole del valore del dono ricevuto, la grazia di parole viventi a cui può attingere a piene mani. E far attingere anche gli altri. Si tratta di una vera morte, seguita da autentiche, concrete resurrezioni, una sequenza di guarigioni e ricadute che dalla clinica psichiatrica la riportano nel mondo dei “normali”, e viceversa.
Alda inizia a scrivere molto giovane; non ha ancora sedici anni quando l’amica Silvana Rovelli, cugina di Ada Negri, mostra alcune sue poesie allo scrittore Angelo Romanò, che a sua volta le fa leggere al critico Giacinto Spagnoletti.
Nel 1947 conosce tre figure fondamentali del mondo letterario: Giorgio Manganelli, Luciano Erba, Maria Corti. In questo stesso anno si manifestano i primi segni della malattia mentale. Spagnoletti inserisce alcuni dei suoi versi nella sua Antologia della poesia italiana 1909-1949, pubblicata da Guanda nel 1950. Altri sono inseriti nella raccolta, curata dall’editore Vanni Scheiwiller, Poetesse del Novecento, del 1951. Il suo primo libro è La presenza di Orfeo (Schwarz, 1953), apprezzato da pesi massimi della letteratura italiana come Montale, Pasolini, Quasimodo, cui seguono altre due raccolte di liriche, Paura di Dio e Nozze romane, entrambe del 1955.
Sei anni più tardi appare Tu sei Pietro, l’opera che chiude il primo periodo della sua produzione.
Segue un lungo intervallo di tempo segnato dalla malattia che la porterà a subire lunghi ricoveri nell’Istituto psichiatrico Paolo Pini di Milano. In ospedale ricomincia sporadicamente a scrivere, anche a scopo terapeutico, ma è a partire dal 1979 che prende avvio la nuova produzione. La riflessione sulla terribile esperienza del manicomio genera le liriche che solo nel 1984 verranno pubblicate da Scheiwiller con il titolo La Terra Santa, che otterrà nel 1993 il Premio Librex Montale.
Dio è onnipresente nei versi di Alda, a volte in modo non esplicito, a volte con i connotati inconfondibili del figlio del falegname di Nazaret, sorgente di continue rinascite e rinnovate creazioni.
Scrive in Corpo d’amore: «Mi ha resa giovane e vecchia / a seconda delle stagioni / mi ha fatto fiorire e morire / un’infinità di volte. / Ma io so che mi ama / e ti dirò, anche se tu non credi / che si preannuncia sempre / con una grande frescura in tutte le membra / come se tu ricominciassi a vivere / e vedessi il mondo per la prima volta. / E questa è la fede, e questo è lui / che ti cerca per ogni dove / anche quando tu ti nascondi / per non farti vedere».
Alda, nata il 21 marzo, nelle sue opere è la messaggera di una primavera che assomiglia all’aldilà, a un mondo alieno che ha il compito di mettere meglio a fuoco la profondità dell’aldiquà.
Non a caso all’inizio della sua lunga e sofferta vicenda editoriale c’è una silloge che ha Orfeo nel titolo: il poeta si lancia nell’abisso per cercare gli dèi fuggiti dal mondo, o almeno per riportarne in superficie le tracce, e la musica. I versi della Merini sono, appunto, una discesa nella notte dell’uomo, ma è una notte illuminata da lampi, popolata di anime e di contrasti, altamente vitale.
Un itinerarium mentis in Deum personalissimo, che può diventare esperienza condivisa solo grazie alla visitazione delle parole, una ricognizione per epifanie, deliri, nenie, canzoni, dello spazio in cui irrompe il naturale inferno e la naturale luce dell’essere umano. Il dolore e la malattia in fondo sono solo il reagente che rende visibili entrambi.
«Ogni poeta vende i suoi guai migliori», diceva la Merini con il suo naturale, abituale understatement: «La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori. Per me la vita è stata bella perché l’ho pagata cara». In fondo, continua Alda, persino Dante fu «un genio miserabile. Il poeta muore spesso».
Ed è questa la chiave per comprendere, chiosava Manganelli, i modi ingegnosi in cui l’altrove si nasconde sotto l’apparenza dell’ovvio: «Di rado è stata più fermamente sperimentata la qualità empirea della parola impegnata nella ricognizione dell’inferno; la felicità dei testi di Alda Merini non è altro che l’incontro con la perfezione del dolore; la salvezza è il battesimo verbale della disperazione».
Profetessa suo malgrado, perennemente in lotta con il suo compito e la sua vocazione di croce e annuncio, delirio e consapevolezza, Alda Merini parla di se stessa sempre con un sorriso dolceamaro: «Comunemente si pensa che si possa scegliere la vita e il genere di vita che più ci compete, ma è difficile per tutti sottrarsi all’impero della nascita, e a quello più urgente del dolore. E del resto dico spesso a tutti che quella croce senza giustizia che è stato il mio manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita».
Di tutte le vite, anche di quelle meno “riuscite” secondo i parametri della mentalità mainstream, e ha reso sempre più concreto e più serrato, negli anni, il suo dialogo con Dio. A chi le domandava come si scrive, rispondeva: «Si va vicino a Dio e gli si dice: feconda la mia mente, mettiti nel mio cuore e portami via dagli altri, rapiscimi. Io scrivo sempre intingendo il mio calamaio nel cielo».
Tutta la sua ampia, variegata opera è un diario senza traccia di sentimentalismo, compiacimenti estetizzanti o di facili condanne in cui emergono variazioni sul tema dello “sperdimento”, quel dimenticare se stessi che è effetto collaterale dell’amore, e ha forza trainante delle passioni più elementari. Ma anche la sicurezza di sé e della propria, singolarissima voce in una sorta di innocenza primaria che osserva e trasforma tutto, lacerando l’abitudine, l’indifferenza e la paura del mondo che c’è “fuori”. Senza mai disconoscere la malattia, con il suo carico di pena costante, ma considerandola una prova da attraversare.
Così lontana e così vicina a tutti noi, la poesia della pazza della porta accanto dei Navigli.
«I pazzi aprono le vie che poi percorrono i savi», scriveva Carlo Dossi a cavallo fra Otto e Novecento. Nel caso della Merini, è successo davvero. «Due giorni prima che morisse», racconta l’amico di sempre Arnoldo Mosca Mondadori, «mi chiese di riscaldarla con un fon.
Poi si tolse la maschera dell’ossigeno e accese una sigaretta. Allora un amico, Silvio Bordoni, le disse: “Ma signora Merini, non è il caso che lei fumi”.
E lei rispose: “Caro Bordoni, oramai mi rimane questa sigaretta e il primo bacio di Gesù”».
Alda Merini (Milano, 1931-2009) esordisce con il suo primo libro di poesie, La presenza di Orfeo (Schwarz), nel 1953.
Nel 1984 pubblica La Terra Santa (Scheiwiller) che le vale il Premio Librex Montale.
Le sue opere sono raccolte nell’antologia Il suono dell’ombra. Poesie e prose (1953-2009), edita da Oscar Mondadori.