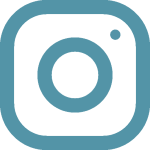Caro Carnevale, non fare coriandoli della mia missiva.
Tu lo sai che ci portiamo rispetto da lontano, ma non siamo mai riusciti a legare.
Provo un brivido se passo accanto ai mimi-statue-egiziane in piazza Duomo, immagina i miei sentimenti nei giorni in cui le strade si chiudono con le transenne perché tu possa trionfare. Non mi piace sentire gridare, né l’odore della schiuma da barba sui muri. Al passaggio dei tuoi carri io mi concentro sulle ruote dei trattori, e mi si avvia la riflessione su quanto siamo poca cosa se persino uno pneumatico può superarmi in statura.
Alcune informazioni sul tuo conto che mi ha dato mio fratello maggiore, da bambino, mi fanno impressione ancora: le fialette in uso a bontemponi che rendono calvi entro due settimane; i bastoni di ferro travestiti da innocue clave di gommapiuma, in grado di uccidere un uomo; i danni al fegato delle frittelle che se ne approfittano del suffisso “di mele”. La tua parata è un baccanale senza ritorno per chi si confronta con certi traumi infantili.
Caro Carnevale, annunciamolo insieme, una volta per tutte, che la tua festa non cade in primavera (diversamente dalle convinzioni delle fabbriche di costumi): i travestimenti sono sempre una indecisa mediazione tra la resa estetica e la sopravvivenza alle temperature polari, così si incrociano fatine in sovrappeso non più in grado di volare per il ripieno di maglioni, molteplici Puffi sciatori e Zorri con guanti e paraorecchie inconciliabili col paesino del centroamerica dal quale dovrebbero provenire.
Niente di personale, ma il divertimento obbligato è un concetto che sta insieme quanto la spontaneità e gli album fotografici dei matrimoni.
Io mi sono vestito dieci anni di nero, tu sei simboleggiato da Arlecchino. Io mi dipingo incerto e saturnino, tu pretendi che metta in discussione la dose minima di identità che negli anni ho provato a raggranellare. Per una volta evita di venirmi a cercare. Ma pure se arrivi, non sai qual è il mio costume.
di Emanuele Fant