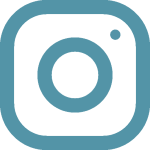Il resoconto di Andrea Miccichè in esclusiva per noi dalla XII edizione del Festival Biblico a Vicenza.
Rosario Livatino, martire della giustizia e della misericordia
Può un giudice diventare esempio dell’opera di misericordia spirituale “Perdonare le offese”?
Il giudice è considerato colui che deve ristabilire l’equità e il diritto, laddove vi è stata una violazione delle norme di convivenza.
Il perdono non rientra, secondo questa visione, nella professione del magistrato, anzi, un comportamento indulgente può apparire una sconfitta di fronte al male.
Tutta questa costruzione “classica” è messa in crisi dalla figura di un testimone, Rosario Livatino, brutalmente ucciso dalla mafia nel 1990, quando aveva solo 36 anni.
È grazie alla vita di questo servitore della giustizia che Papa Giovanni Paolo II, dalla Valle dei Templi, ha lanciato quell’anatema contro i mafiosi ed è ancora grazie a lui che il suo assassino, Domenico Pace, ha iniziato un cammino di conversione, vivendo la giusta condanna come un momento per riflettere e riparare il male compiuto.
Durante la XII edizione del Festival Biblico a Vicenza, il compito di riscoprire la sua figura è stato affidato a coloro che hanno raccolto, a diverso titolo, il suo testimone: don Luigi Ciotti, fondatore di “Libera” e il prof. Nando Dalla Chiesa, figlio del generale Carlo Alberto, prefetto di Palermo.
Come ha affermato Dalla Chiesa, il giudice ragazzino – così è passato alla storia – era lontano dai riflettori. Non era conosciuto, né voleva balzare agli onori della cronaca. Anzi, il giorno della morte, nessuno era consapevole della grave perdita per lo Stato. Era un giudice, e tanto bastava. La sua riservatezza, la sua mitezza, coniugate con il senso della fede e della missione di servitore dello Stato, hanno fatto di lui un uomo solo. Solitudine che ancora oggi denota coloro che fanno il proprio dovere senza aspirare alla gratificazione, al riconoscimento, consapevoli che già praticare la giustizia è la ricompensa più grande.
La giustizia, infatti, a differenza del giustizialismo, non gode della condanna inflitta, ma si compiace quando raggiunge l’obiettivo della legalità.
Ricorda Dalla Chiesa: “In Livatino, il lato umano, professionale e spirituale si fondevano l’uno con l’altro in assoluta coerenza e continuità. Bravo a scuola, ma non un secchione, era il primo ad aiutare i compagni in difficoltà, ma era anche rigoroso e intransigente verso se stesso, tanto da rinunciare, durante lo svolgimento di un compito in classe, a copiare dal suo compagno anche se in preda a un febbrone. Ma questa aderenza totale alle regole e alla legalità non gli avrebbe impedito di dimostrare altrettante doti di generosità: mandava in carcere chi doveva mandare in carcere, ma in assoluto silenzio si levava parte dello stipendio per sostenere le donne e i figli di chi aveva, giustamente, punito per la sua colpa”. Condannava la colpa, non il peccatore: non voleva che la colpa di uno si diffondesse a macchia d’olio sugli altri.
Sapeva che il male si combatte nel silenzio, ostacolandone la diffusione, specialmente mediatica.
Non solo: nella sua umanità, rispettava anche il nemico. Quando un boss mafioso venne ucciso durante una sparatoria, davanti alla reazione di contentezza di un ufficiale di polizia, giunse a richiamarlo all’ordine con una frase lapidaria: “Di fronte alla morte chi ha fede prega, chi non ce l’ha resta in silenzio”. Le sue ultime parole, prima di morire, sono il più alto esempio di misericordia: non ha maledetto o condannato gli assassini, ha chiesto: “Cosa vi ho fatto, picciotti?” L’uso di una parola del dialetto siciliano, che indica proprio una vicinanza, una prossimità, è la cifra della grandezza di quest’uomo davanti agli uccisori. La sua giustizia comprendeva anche i delinquenti, perché aveva come obiettivo il loro riscatto dal vortice di male in cui erano immersi.
In un intervento tenuto il 30 aprile 1986 dalle suore vocazioniste di Canicattì, Livatino smentisce il presunto antagonismo tra carità e giustizia, richiamando il compito difficilissimo della decisione, che per il magistrato credente diventa “realizzazione di sé, preghiera e dedizione a Dio, in un rapporto diretto con Lui”, nella cancellazione di ogni vanità e superbia personale.
Commentando il passo evangelico in cui Cristo afferma la sua missione di compimento dell’antica Legge mosaica, Livatino sosteneva che la giustizia è necessaria alla società, ma non basta; l’uomo non può vivere in funzione della legge, ma, nella carità, renderà la legge uno strumento di pace.
Nel suo servizio, il giudice darà vita concreta ed effettiva ad un comando astratto, nella consapevolezza del fine ultimo che deve perseguire: ricostruire la persona umana. Nell’anno della Misericordia, dunque, tra i testimoni-martiri, Livatino è quello che intercede, secondo la forte immagine di don Ciotti, perché il Signore possa darci “una bella pedata” affinché ci assumiamo la responsabilità andare avanti senza trionfalismi da una parte, né senso di impotenza dall’altra, e perché possiamo essere giusti e misericordiosi, in prima linea a condannare il male, ma altrettanto pronti per curare le ferite provocate dall’iniquità.