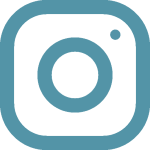Ai vostri figli non raccontate di essere dei perfetti supereroi, ma dite loro: «L’amore da cui sei nato, c’è ancora»
«Mamma, il pericolo è il tuo mestiere. «Oddio, non direi. Anche se alla fine lo scivolone kamikaze in piscina l’ho fatto». «No, dicevo che è la mamma il mestiere più pericoloso. Fai un figlio, e non sai quello che ti capita. Poi te lo devi tenere tutta la vita. Con me ti è andata bene». Non l’avevo mai pensata così, in effetti, e a vederla da questa angolatura fa un po’ paura, più del kamikaze (l’addetto alla piscina mi ha assicurato che non era mai morto nessuno lanciandosi dal tubo giallo, comunque, e non ha fatto nessuna osservazione spiritosa sul fatto che sembravo seduta su un bidet quando sono scesa). Essere una famiglia significa consegnarsi per sempre a delle persone a cui sarai legato per tutta la vita (e con un figlio non sai mai chi ti metti in casa, come diceva Achille Campanile). La cosa può dare una certa vertigine. Per sempre, soprattutto in quest’epoca dello spontaneismo in cui viviamo, è un bel po’ di tempo.
È un bel po’ di tempo, e a volte può essere anche un bel po’ di fatica. Non parlo tanto delle emergenze, dei momenti di difficoltà particolare, un problema economico, una crisi di coppia (articolo diffusissimo sul mercato, al momento), una malattia, quanto dell’ordinaria amministrazione – per quanto “ordinaria” a casa mia sia spesso una parola azzardata: oggi pomeriggio mi sono ritrovata a un certo punto che facevo panini al prosciutto per undici ragazzini, spuntavano da sotto i divani come i calzini, i ciuffi di polvere e le carte di caramelle (la flora dei miei sottodivani fornisce un habitat favorevole alla proliferazione di forme di vita non ancora studiate dalla scienza, che si nutrono di panini: figli, nipoti, figli dei vicini, amichetti di passati cicli scolastici che sanno di poter sempre contare su di noi).
È un bel po’ di fatica anche la normale fedeltà al quotidiano, quel consistere, semplicemente, quello stare al proprio posto in trincea, giorno dopo giorno dopo mese dopo anno, cercando di fare bene il proprio mestiere di moglie o marito e di padre o madre, per quanto, diciamo la verità, su questo il mio obiettivo si è piuttosto ridotto negli anni, da quando sono uscita la prima volta dalla sala parto, col manuale tipo “cresco il mio bambino” tutto sottolineato e il fermo proposito di non contaminare la bocca del pargolo con qualcosa che fosse men che biodinamic-natural-artigianal-biologico, per poi passare repentinamente dalla zucchina immacolata a un’alimentazione a base di grassi saturi e coloranti: insomma sono passata dal target mamma perfetta alla speranza di essere almeno decente, dal tentativo di non sbagliare niente, al desiderio di averne azzeccata almeno una tra tanti errori, così, giusto per il calcolo delle probabilità, per la legge dei grandi numeri (a forza di fare, qualcosa di buono lo avrò prodotto, no?).
Eppure, anche questa fatica di essere decenti, vale la pena, eccome, vale veramente la pena. E non parlo di valori, parola che, almeno in me, ingenera attacchi di sbadigliarella, il desiderio di andare di là a versarmi un Cuba libre (purtroppo però non posso, sono astemia) o il progetto di scappare in Papuasia Nuova Guinea con un passante. Se rimaniamo al nostro posto non è certo per i valori. Se rimaniamo è perché abbiamo capito che la famiglia è l’unica cosa che veramente funziona, è quello per cui siamo fatti, è quel posto in cui il gioco non prevede che io vinca solo se tu perdi, ma al contrario è dove si vince solo tutti insieme, e nessuno perde. La famiglia è quel posto in cui si può dare il peggio e sempre essere accolti, e anche se è bene che non diventi un’abitudine, si sa che a casa si può essere ogni tanto anche un molto scorbutici avendo pure torto, o ballare I will survive in mutande, o cucinare per la quinta volta della settimana pasta in bianco, e rimanere “la mamma dei miei sogni”. La famiglia è quel posto per cui vale la pena risparmiare, perché si sa che ogni piccolo sacrificio fatto farà stare bene qualcuno che amiamo. La famiglia è quel posto in cui non serve neanche tanto enunciare princìpi, soprattutto con i figli, perché loro ascoltano con gli occhi, e imparano solo quello che vedono vivere. La famiglia è una specie di rifugio antiatomico, a volte, che può anche essere esposto, fuori, alle peggiori radiazioni nocive, senza paura, anche eventualmente con allegra incoscienza, perché contiene in sé tutti gli anticorpi. È anche quel posto dove tornare dopo che si sono fatte le peggiori stupidaggini, perché i figli attraverseranno la loro Babilonia, inevitabilmente, prima di approdare alla Terra Promessa. L’importante è che qualcuno sia rimasto a casa, a garantire il ritorno.
«La Canada dry perché piace a Livia e Bernardo, la Pepsi twist a Lavinia, un Chinotto per Tommaso…». Guardo ammirata mio marito che prima della grigliata in giardino tira fuori dalla busta della spesa le bibite per i nostri figli, dei quali probabilmente non saprebbe elencare esattamente i nomi delle scuole né le classi frequentate; di sicuro non ricorda mezza malattia infettiva che hanno avuto, né le saprebbe attribuire al figlio abbinato, ignora l’ubicazione dell’ambulatorio della pediatra, ricorda appena, vagamente che abbiamo un mobiletto dei medicinali ma solo perché c’è anche l’Aulin per il suo mal di testa, confonde i compagni di classe dei quattro e va al saggio di danza con le notizie del calciomercato nell’auricolare (la mia amica Paola sostiene che un padre che non si scoccia al saggio è al limite del transgender). Eppure sa quale figlio ama la coca alla ciliegia, fatto che per me ha del prodigioso.
Io in compenso non sono addetta alla spesa, e mi confondo nomi di bibite, caramelle, schifezze a elevato contenuto di grassi; non so giocare bene come lui, non sono una fonte affidabile di informazioni su un’enorme parte dello scibile umano – e guarda caso quella che interessa di più alla nostra prole: storia, politica, musica, cinema… So che ognuno di noi due ama come può, meglio che può, dando quello che può. E so che sarà abbastanza, perché è tutto l’amore che abbiamo in corpo. Questo amore limitato, squinternato e ferito – anche i genitori si portano dietro le loro storie – comunque dirà loro una sola cosa. Che vale la pena vivere. Che la vita è una cosa grandiosa, bella, bella, bellissima. Questo vogliono sapere da noi i figli, e vogliono guardarci, noi due, e vedere che quell’amore da cui sono nati c’è ancora. Per loro è una garanzia, è il permesso di esistere, il permesso di essere anche brutti, sporchi e cattivi, perché contenuti da un abbraccio più grande di loro, più di qualsiasi ombra possa mai oscurarli, un abbraccio che li trascende, e che non aspetta niente da loro in cambio.
Per questo, il modo migliore per amare i nostri figli è amare il loro padre, la loro madre. Mettere il lavoro della famiglia al primo posto, e non lasciare che finisca all’ultimo, che allo sposo, alla sposa, rimangano le briciole delle energie, della creatività. È quella che io chiamo la mia “crociata contro le mutande ascellari”, che serve a ricordare alle donne che non è necessario, dopo qualche anno di matrimonio, mettere pigiamoni respingenti felpati o mutande comode. Non è obbligatorio smettere di sorridere. Non è prescritto dalla legge mettersi i vestiti da casa quando si rientra, tenere la famosa maglietta bucata per quando ci vede l’unico che avrebbe diritto ad avere il meglio di noi.
È invece altamente consigliato ricordare alcuni semplici dati essenziali. Per esempio che l’esemplare dell’altro sesso di cui ci siamo dotati in modo permanente pensando che fosse la nostra anima gemella è in realtà una strana creatura proveniente da un altro pianeta, e dotato di alcuni meccanismi base di funzionamento del tutto diversi dai nostri: si sa che i maschi procedono con un pensiero tubolare, e pensano e fanno una cosa alla volta (non fate mai a un uomo la cattiveria di chiedergli un’opinione sul vostro taglio di capelli mentre sta smanettando al Blackberry. Non si è minimamente accorto che siete state dal parrucchiere, e se si sforza troppo finirà per cestinare la mail che aspettava con ansia). Si sa anche che gli uomini dicono esattamente quello che intendono dire – parlano una strana lingua in cui le parole significano solo quello che significano – e non sanno che per noi femmine ogni parola è portatrice di un fitto groviglio di rimandi occulti, fatto che li porta a cadere incautamente su alcune scivolose conversazioni (per una donna dire “non importa, ce la faccio da sola” di solito significa “se non mi aiuti allora dillo che non mi vuoi bene”; e per lei chiedere “come sto con questi pantaloni?” non significa attendere un parere sincero ma esigere un complimento anche piuttosto esagerato, per non parlar della domanda delle domande – “mi trovi ingrassata?” – che è una falsa domanda, visto che prevedere solo la risposta standard “macertochenomiacaraseimoltotonica”, l’unica ammessa).
Imparare a tradursi a vicenda è un lavoraccio, ma significa percorrere una parte di quella distanza misteriosa nella quale è nascosto il segreto di Dio, che ci ha creati maschio e femmina, a sua immagine (per quanto nella Genesi non sia assolutamente specificato a chi spetti lo scettro del telecomando, ci tengo a precisarlo).